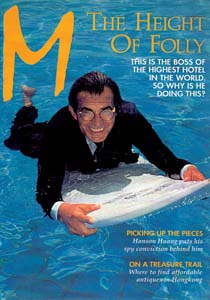|
|
||||||
|
||||||
| Ernesto Barba figlio del sole |
||||||
| Maurizio Nocera | ||||||
|
Cominciai a |
Ernesto scrisse anche di aver avuto «cura di non dire la verità vera», cioè che il Tibet era magico e che (avrebbe) vissuto l’esperienza dell’uomo tantrico: «Finalmente, dopo battaglie burocratiche con il Partito Comunista Tibetano, il Public Security Bureau e il Foreign Affairs Office, (Ernesto Barba fu) autorizzato a frequentare sia i corsi del Collegio Tantrico che la biblioteca di Sera, l’università-monastica… La logica buddista non (lo) elettrizzò, i 108 volumi del Kanjur e 225 trattati del Tanjur troppo da specialisti, da buon Dharma-bum (cercò) di mettere in pratica la frase d’Alan Watts: “Ogni religione è una tecnica per mettersi in contatto con l’Invisibile”. Così prese la consacrazione di Yamantaka per essere pronto al confronto cogli Archetipi. (Lo) aveva traumatizzato un verso di Borges che, rivolgendosi a Heine, (gli aveva chiesto): “Tu che hai cantato usignoli e pleniluni che starai facendo ora, faccia a faccia con gli Archetipi?”».
Ernesto fece poi un’affermazione importantissima per un europeo che andava sperimentando l’Himalaya. Che è questa: «Rubai come un volgare Gasparone da strada maestra quante più mantra mi fosse possibile. (Perché nel Tibet solo il brigantaggio spirituale ti fa progredire. Non c’è assistenzialismo a livello sottile). Poi, quando ne (ebbe) raccolte un pacchetto, da quelle a sei sillabe a quelle – segretissime – di cento (una persino di cento e otto) (si) accorse d’aver fatto un lavoro di robi-vecchi pulisci cantine perché, come Dada Vishevarananda (gli aveva detto), e lui di mantra sì che se ne intendeva: «Le Mantra del Mahayana sono completamente inutili e non possono applicarsi alla Kalì Yuga. Dopo tremila anni dalla nascita di Sakyamuni le Chakra hanno subito involuzioni tali che c’è bisogno d’altre mantra più forti, più dirette, vive per farti diventare vivente», e così mise in crisi tutto un sistema. (Ernesto), comunque, riuscì ugualmente a (farsi) dare l’iniziazione di Tara, e qui se non altro, forse, (fece) qualche passo avanti. (Entrò) in un paio di Mandala; come Figlio del Sole (gli) fu facile trovare il passaggio dalla porta dell’Est (che poi è a Sud). Gli unici testi sui quali veramente (si) applicò (Nagarjuna troppo moderato, Shantideva troppo beghino), oltre naturalmente al Bardo, furono Le invocazioni del nome di Manjusri, perché così volle il (suo) Geshè, il (suo) maestro (era l’incarnazione di Shewei, il discepolo favorito di Milarepa. Perfino Paris-Match lo conferma, come fai a dirgli di no?), i Tara-Tara del Primo Dalai Lama (il più bel libro letto nell’anno 1991... e Le Visioni del Grande Quinto. Queste fecero addirittura impazzire (Ernesto), erano il (suo) trip giusto, (lo) riportarono alle passioni della (sua) gioventù beatnik, quando sbarcato la prima volta a San Francisco, aspettando Miss Chinatown 1962, che era l’hostess della Pan Am e quindi sempre in ritardo, in un caffè di North Beach, mentre un folk-singer cantava: I cannot stopo to wonder / where I’m bound / where I’m bound, (lesse) per la prima volta Timothy Leary, (che) (lo ebbe qualche anno dopo come ospite in una residenza-forzata nell’albergo dove lavorava a Kabul...). Le Visioni del Quinto Dalai Lama hanno, secondo gli esegeti, sette livelli di letture. (Ernesto fu) capace, come un surfer aggarra l’onda buona, di aggarrarne solo tre e in questo (fu) aiutato dai commentari del Sesto Dalai Lama. Così lo conobbe... A Lhasa. (Egli) venne preso per mano (da) Tsangyang Gyatso, il Sesto Dalai Lama. Il Signore che fa? Ruota. Che siano nei tarocchi o nei cicli temporali le ruote girano e cambiano livelli anche se la materia è statica. Lhasa ha cambiato di livello. Il Potala, il Palazzo di Cherensig il Buddha patrono del TIbet, la fortezza imperiale dei Dalai Lama, che Tsangyan Gyatso bambino modellava con la creta dicendo «Questo è mio», è ora un bene culturale della Repubblica Popolare Cinese. Senza più il Genius Loci, il Potala serve solo a fare da sfondo alle foto ricordo e a dividere, messo così a fermacarte, i nuovi quartieri cinesi della città vecchia tibetana. Ma tutt’intorno al Potala, in quello che era il quartiere di Zhol, nel parco del Lhukang, così decadente e fatiscente, nel Lhinkor il percorso rituale che i pellegrini fanno prostrandosi ogni due metri. Lui è presente, anche se le ruote girano. Alto, bello, con un mantello allo stile del Buthan, conoscitore di segreti tantrici e di femmine, arciere, cavaliere, poeta da taverna, re degli amici, giocatore di dadi, suonatore di flauto, astrologo, dissoluto, patriota, martire ideologico, ballerino, tiratore di coltello, monaco sfratato, principe ereditario, asceta, pellegrino, innamorato pazzo, prigioniero politico, sciamano e dottore mirabilissimo in Scienze Sacre.
Oltre che essere la reincarnazione ufficiale, omologata di Cherensig,
l’Avalokiteshvara sanscrito, il gran Bodhisattva della Compassione
con tutti i 32 segni nel corpo attestanti la ierofania della sua
essenza divina. Sul finire dell’anno 1992, Ernesto Barba fece definitivamente
la scelta di abbandonare il Tibet. Un po’ rammaricato, mi scrisse:
«Addio Lhasa bella mia, sempre sorridente come una tigretta
conosciuta nelle balere-disco dietro lo Shambala Restaurant, piene
di ufficialesse dell’Esercito Popolare ed agenti della polizia
segreta. Addio Lhasa, sventola le tue bandiere d’orazione,
gira i tuoi mulini di preghiera, io emigro in patria. Un bacio e
addio Lhasa anche se tu non baci mai proprio come una Kampa incoronata
di turchesi nelle sue centotto treccine. Addio Lhasa, anzi come
abbiamo imparato a dire qui, con l’accento tonico sbagliato,
Ka-li-sho».
A caso, scelgo i versi del Sesto Dalai Lama tradotti da Ernesto, ma so già che questi sono i più belli, sono i versi che piacevano a lui Marra-Barba, sfortunato/disperato giocoliere di nuvole dorate; che piacevano al mio amico Antonio Verri, anche lui sfortunato/disperato e abbattuto sull’antica via Malemnia Lecce-Cavallino da una vecchia civetta malridotta eppure cornuta; che piacciono pure a me, sfortunato/disperato vecchio rimbambito giocatore attarantato che finge di non vedere la gatta sorniona che aspetta sul davanzale di sopra. Ernesto Barba dunque traduttore. Traduttore di cose divine (Verri avrebbe poi precisato: di-vini). Ecco il testo: «Profumava dolce dolce la bella che incontrammo in viaggio. Un turchese bianco senza valore, che trovammo e poi gettammo. / I pensieri trascinati lontano, le notti così senza sonno. Senza lei, la fatica e la pena e i giorni senza ritorno. / Passata la stagione dei fiori e l’ape turchese è serena. Il nostro amore è passato ma nessuna tristezza mi aspetta. / Innamorato del lago il cigno voleva restare. Ma quando il ghiaccio venne a lui non restò che volare. / Continua la polena del traghetto a guardare indietro il guado. La bella mia – ingratitudine dispetto – neanche mi dà uno sguardo. / Parole d’amore in inchiostro blu, distrutte da una goccia di pioggia. Ma anche non scritto l’amore non lo cancelli dalla memoria. / Se la bella mia abbracciasse la via, la via del Dharma, in montagna mi ritirerei in giovinezza eremita. / Se avessi vissuto per il Dharma invece di pensare a quello che penso, fratello io sarei andato oltre in questa stessa vita già. / Tavernella delle donzelle belle, denti bianchi e luccichìo lei mi scintillò un sorriso, l’amore in un batter d’occhio. / Completamente innamorato, le chiesi “Vieni – resta da me”. “Verrei – lei disse – solo se la morte ci separerà”. / Seguo i suoi desideri profondi e perdo per sempre la via. Ma se mi allontano dal mondo spezzo il cuore alla bella mia. / Io povero cacciatore catturai Yitrog, la Fata d’incanti. Venne Norzang, il Signore dei morti, e me la soffiò via. / Si sono rubata la bella mia e un altro l’ha sposata. Pieno di pensieri neri che m’hanno disseccato il corpo. / Bisogna che lei viva in eterno, che l’hashish non sia mai spento. Con lei, mia tana sicura, mi sento felice e contento. / Ma ha avuto una mamma vera o è nata da un albero di pesche? L’amore che sembra darti davvero sfiorisce come un pesco in fiore./ E’ la bella mia a letto veramente cugina del lupo? La lupa viene a gozzare la carne e poi allupata alla monta. / Mai trottare a cavallo sul lago gelato. Mai svelare un segreto a un amore appena trovato. / La luna alla sua terza notte è tutta luce e brillìo. Me lo devi promettere pleniluna ti voglio io. / Tigri, molossi, leopardi, dài da mangiare e si quietano. Ma pure saziata la bella mia diventa più feroce, coi capelli al vento. / Scrivo numeri sulla sabbia e trovo l’altezza delle galassie, carezzo il suo corpo dolcissimo dolce e non so giù giù nel profondo che sente. / Sa bene il pappagallo parlante a non dar via il segreto. A Lhasa ce ne sono tante, ma a Chunghay son tutte belle. / Nevicava forte sul tardi quando andai dall’amante mia. All’alba il segreto è violato, le mie impronte lì sulla neve. / Quando abito al Potala, al palazzo mi chiamano “Oceano di melodia divina”. Quando scendo a Lhasa o a Shol sono “Strappafemmine e Bello Potente”. / Le mie impronte lì sulla neve. Segreti, non segreti, finito. Io a letto con la bella mia, il cuore di conchiglia bianca e il corpo dolcissimo dolce. / Ha fatto segno la freccia e la punta si conficcò nel terreno, quando incontrai la bella mia il mio cuore la seguì in un baleno. / Quello che la gente dice di me, ahimè è tutto vero. Il signorino pulito e bello a passi leggeri andò nella taverna-bordello». Nell’ultimo pacco che mi giunse da Lhasa, Ernesto c’aveva messo anche una lettera. Dopo alcuni anni, attraverso i suoi scritti, provenienti dal lontano Tibet, mi sembrò di conoscere e di vivere quegli altissimi luoghi. In essa c’era scritto: «Caro Maurizio, ho finito con Lhasa e il Tibet. Triste lasciare un posto così (e con femmine così), ma due anni a meno zero sono tanti. Resterò un mesetto tra Taipei e Pechino per regolare degli affari futuri. Penso di tornare in Italia sotto Natale (1992) perché a gennaio comincio a lavorare per una compagnia italiana che si occupa di marketing turistico. Sarò di base a Livorno, ma in pratica sarò sempre in giro. Dopo due anni di sedentario è bene riprendere, magari per l’ultima volta, a girare. Ti mando, con tantissimi auguri e tantissimo affetto, un biglietto che mi sono divertito a fare specialmente per gli amici (e anche se non ci vediamo tu sei nei top ten) nel tremendo inverno tibetano, mentre preparavo il mio master in Storia delle religioni (sono l’unico direttore di hotel al mondo Dottore in Buddismo Tantrico!). Non ha nessunissima pretesa e spero ti piacerà. Dunque tantissimi cari auguri, caro Maurizio, e la speranza, prima o poi, di ritrovarci nel Salento magico». Dopo quest’ultima lettera, continuai a cercare Ernesto con
ogni mezzo, ma molti dei miei messaggi cominciarono a ritornare
al mittente perché il committente non risultava trovarsi
nei posti indicati. Ernesto Barba decise allora di farmi perdere definitivamente le
sue tracce. Dopo avermi lasciato un tesoro immenso qual era la sua
poesia (fra cui molti inediti), decise di occultarsi definitivamente
ai miei occhi. Per questo, agli inizi del 1994, allorquando Antonio
Verri se n’era già andato via per sempre, cominciai
con dolore e sofferenza a lavorare all’introduzione per una
sua nuova raccolta di liriche, non dimenticando la sua volontà
di firmarlo, lui in vita, solo col suo pseudonimo: Francesco Marra.
Di tanto in tanto mi venne recapitata ancora qualche sua cartolina
e qualche lettera, ma sempre senza l’indirizzo del mittente.
E questi: «Terza età // Maurizio, / camminando a zonzo
/ ho scoperto / dietro il lago Imperiale / il Parco dei Vecchi di
Pechino. // Chi giocava alle carte / chi giocava agli scacchi /
chi suonava la mandola / chi una specie di violino. // C’era
uno che portava / i cardellini a spasso / e un altro invece il nipotino.
/ Un’allegria, un chiasso... / Nessuno a pisolare / nessuno
che leggeva un libro, un giornale. / Tutti a fumare / tutti a canticchiare
/ tutti a raccontare storie. / Ti dico io un casino. // Maurizio
/ vecchio mio / guarda che cosa ho imparato in Oriente / guarda
che cosa ho scoperto a Pechino / forse diventare vecchi / è
meglio che essere bambino». (3 - Fine. Le precedenti puntate su “Apulia” |
|||||
|
||||||
|
Tutti i diritti riservati © 2004 |
||||||