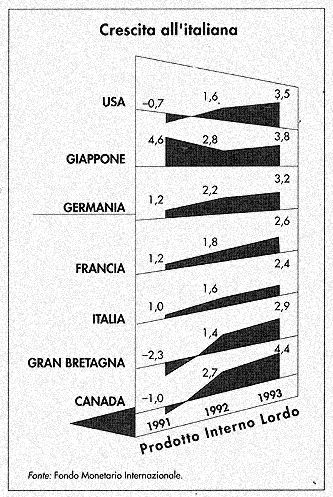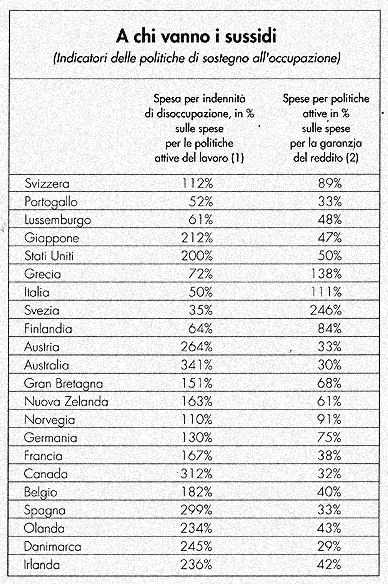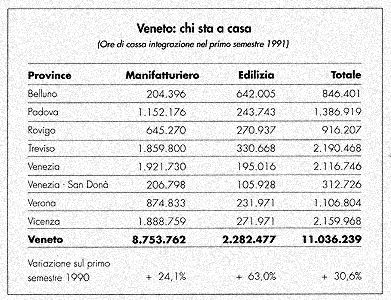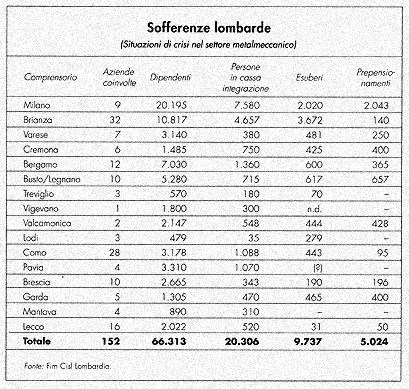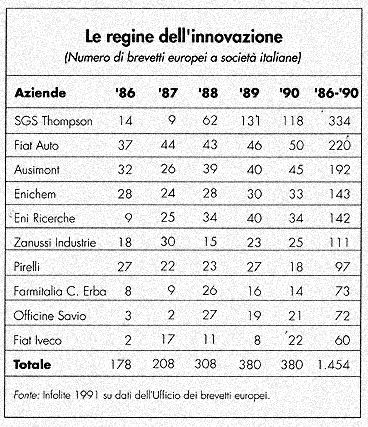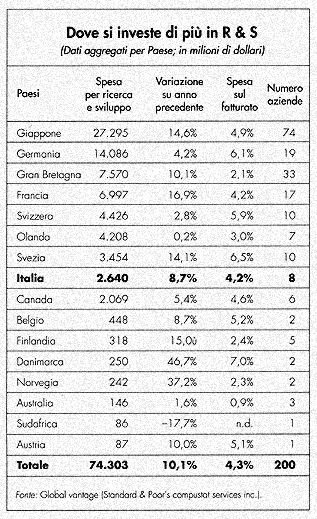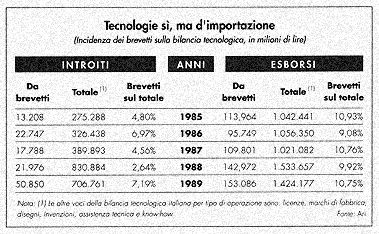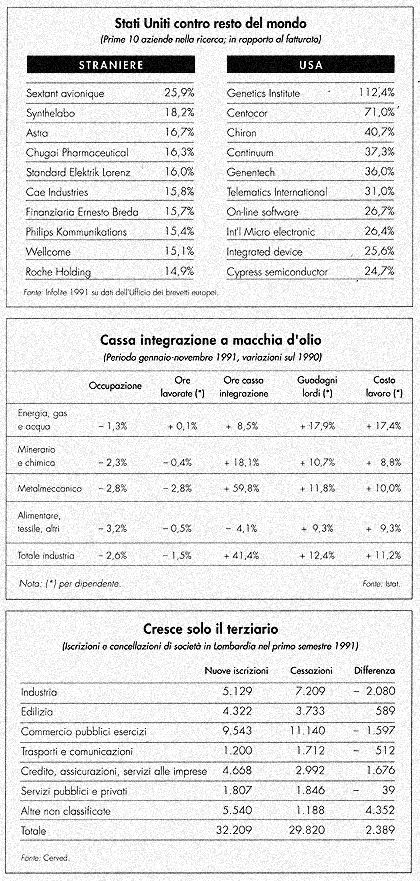1
- Un'epoca di aspettative al ribasso.
A detta di Paul Krugman, noto economista di Chicago, la classe media
americana sembra ormai in preda ad un virus: l'avvento di un'epoca di
aspettative al ribasso, in cui l'unica vera preoccupazione è
quella di ridurre il debito pubblico e l'inflazione. In cui nessuno
si sogna più di chiedere un aumento delle possibilità
di lavoro, una redistribuzione meno iniqua della ricchezza, un aumento
del reddito reale, il cui livello è fermo dal 1978.
Anche in Italia sta accadendo la stessa cosa. inflazione e debito pubblico
sono le maggiori preoccupazioni del nostro Paese, che deve fare i conti,
nell'immediato, con la politica monetaria tedesca, nel futuro, neppure
tanto remoto, con l'impegno solenne preso a Maastricht di contenere
il deficit annuo al 3% del Pil e di riportare il debito pubblico ad
un livello non superiore al 60%.
E così, anche in Italia la gente si rassegna e attende il momento
in cui queste aspettative al ribasso si saranno avverate per poter avanzare
qualche altra pretesa. Secondo Krugman, "se ci fosse giustizia...
il popolo insorgerebbe e caccerebbe i colpevoli. Ma naturalmente non
c'è giustizia... E' non solo possibile, ma addirittura probabile,
che disavanzi di bilancio più o meno del livello attuale continuino
per il resto del secolo ......
Parole queste che valgono solo per l'economia americana?
Probabilmente no. Ma in Italia, si replica, non si può più
temporeggiare, non foss'altro perché esistono precisi impegni
con l'Europa.
Certo, qualche dubbio potrebbe sorgere, se si considera che i nostri
governi hanno disatteso puntualmente ogni impegno di bilancio da molti
anni a questa parte. Che l'Europa faccia veramente paura? Meglio diffidare
e guardare le cifre.
La Finanziaria per il '91 conteneva previsioni cupe: in assenza di interventi,
il fabbisogno tendenziale avrebbe superato le entrate di 180.000 miliardi.
L'obiettivo del governo era quello di ridurre tale fabbisogno a 132.000
miliardi. Ma a marzo esso tendeva già a 190.000. A maggio, imprese
e autonomi disertavano l'appuntamento con il fisco, dichiarando redditi
del tutto irrisori. Sarà stata pure colpa della recessione, come
si è detto, ma intanto il fatidico "tendenziale" raggiungeva
i 199.000 miliardi. Non restava altro che recuperare parte di quel fabbisogno
dagli anni a venire, ossia dal '92, attraverso l'aumento dell'acconto
Irpef e Ilor, e dal '93, attraverso l'anticipazione dell'Invim decennale.
Da queste tre manovre si è riusciti a ridurre il deficit di 57.000
miliardi, (due terzi dei quali vanno alla c.d. "componente temporanea").
Ma il tetto dei 132.000 viene comunque ampiamente sfondato. E il 191
si chiude con un deficit di 152.000 miliardi.
Anche il '92 sembra intriso di voglia di risanamento. Diciamo sembra
sia per la scarsa affidabilità che, di fronte ai risultati concreti,
hanno dimostrato di avere le previsioni o, meglio, gli intenti ufficiali
e sia perché, nei primi quattro mesi dell'anno, i nostri politici
sono stati molto più attenti a riconquistare la propria egemonia,
rimpiazzando di promesse gli elettori, che a mettere veramente in ordine
i conti pubblici. In ogni caso, le manovre previste nella finanziaria
del '92 non si discostano dalla linea seguita nel '91. Per lo più
si tratta di manovre contingenti (condono, dismissioni, rivalutazioni
dei beni delle imprese), che non lasceranno alcuna traccia nel futuro.
Sui loro risultati in termini di riduzione del debito pubblico aleggiano
numerosi dubbi. Ma si spera molto nel '93. Secondo gli economisti, infatti,
la finanziaria del '93 sarà quella della verità, quanto
meno perché non sarà più possibile rinviare negli
anni a seguire il fatidico risanamento, con il rischio di essere esclusi
in via definitiva dall'unione monetaria. Cerchiamo a questo punto di
delineare i possibili scenari. Il primo si basa sull'ipotesi più
realistica, e cioé che la manovra del '92 non vada pienamente
a buon fine e che, quindi, non siano raggiunti tutti gli obiettivi da
essa previsti. In questa prospettiva, il fabbisogno del '93 si aggirerebbe
intorno ai 200.000 miliardi di lire, analogo a quello che era stato
calcolato lo scorso maggio, prima delle manovre escogitate nella seconda
metà del '91.
L'altro scenario, a prima vista più roseo, è redatto dall'Ispe,
l'Istituto di studi per la ricerca economica. L'ipotesi di partenza,
opposta a quella da noi avanzata, è che la manovra del '92 raggiunga
tutti i suoi obiettivi, anche quelli più problematici, come il
condono, la dismissione dei beni pubblici e, soprattutto, il blocco
dei salari all'inflazione programmata.
In realtà, è sul raggiungimento di quest'ultimo obiettivo
che si basa il risultato finale di questa esercitazione econometrica.
Il blocco dei salari, infatti, consentirebbe di mantenere basso il livello
di inflazione, come pure l'andamento dei tassi e della spesa per interessi
sul debito pubblico.
Ma anche prendendo per buone e realizzabili queste premesse, sarebbero
risolti tutti i nostri problemi con l'Europa? Riteniamo di no. Sarà
bene, infatti, ricordare le preziose regole d'ingresso all'unione europea
definite nel vertice del dicembre '91.
Alcune le abbiamo già citate: un deficit statale non superiore
al 3% del Pil e un debito pubblico inferiore al 60%. Le altre sono:
un'inflazione che non superi di 1,5 punti percentuali la media dei Paesi
più stabili e tassi di interesse a lungo termine che non superino
più di due punti la media registrata in quegli stessi Paesi.
Ma allora basta guardare le stesse cifre elaborate dall'Ispe per accorgerci
che, pur verificandosi le ipotesi di partenza, il nostro Paese sarebbe
sempre troppo lontano dagli obiettivi di convergenza indicati a Maastricht.
Senza ulteriori manovre, ci troveremmo comunque con un deficit pubblico
che oltrepassa i 162.000 miliardi di lire, contro il limite comunitario
di 48,7.
In rapporto al Pil, tale deficit si assesterebbe sul 10%, molto al di
sopra di quel 3% richiesto per entrare a far parte dell'unione europea.
Risultato: un debito pubblico pari a un milione 755 mila miliardi di
lire, pari cioè al 107,5% del Pil. Gli interessi medi sui Bot
salirebbero all'11,4%, anch'essi fuori dal margine di tolleranza del
10,1%. L'unico risultato positivo sarebbe in definitiva quello relativo
all'inflazione, che scenderebbe al 4,4%, al di sotto quindi della soglia
del 4,6% risultante dagli impegni di Maastricht.
Considerando che per ottenere questi scarsi risultati si è ipotizzata
la piena realizzazione della manovra del '92, è chiaro che questo
scenario non si differenzia sostanzialmente dal primo, ma finisce per
confermare la situazione veramente catastrofica in cui versa il nostro
Paese. D'altro canto, la realtà contraddice tutte le più
rosee previsioni sul contenimento del deficit che, per rientrare nei
limiti, dovrebbe subire tagli pari a 755 mila miliardi, i due terzi
del deficit stesso. Un obiettivo comunque irrealizzabile in breve tempo.
Ne è cosciente anche l'Europa. Tanto che nell'accordo di Maastricht
si èspecificato che la Comunità potrebbe consentire all'Italia
di aderire all'unione monetaria se solo riuscirà a dimostrare
di aver imboccato la strada della convergenza.
Per far questo, secondo l'Ispe, il primo passo da compiere è
quello che i tecnici chiamano dell'invarianza del debito pubblico rispetto
al Pil. Ciò significa bloccare l'aumento di questo rapporto,
impedendo che la crescita del debito superi il livello dell'inflazione.
Il secondo passo sarebbe quello di abbassare progressivamente questo
rapporto.
L'Ispe ipotizza che, per il '93 e per il '94, sia messa in atto una
manovra che tenda a trasformare il deficit primario, al netto cioè
della spesa per interessi, in un attivo che compensi almeno in parte
quella spesa. Senza ovviamente strangolare l'economia, per le inevitabili
ripercussioni che altrimenti si avrebbero sia sulle entrate fiscali,
e quindi sull'obiettivo di contenimento del deficit primario, sia sui
tassi, che in tal modo aumenterebbero assieme alla spesa per interessi.
Questa manovra dovrebbe consentire di recuperare, nel '93 circa 27.000
miliardi, nel '94, 47.700.
Così facendo, nel '93 il debito pubblico salirebbe a 1 milione
704 mila miliardi di lire, ossia al 105,4% del Pil. Il fabbisogno del
Tesoro si attesterebbe su 121.400 miliardi, pari al 7,5% del Pil. Nel
'94, il debito crescerebbe a 1 milione 812mila miliardi, ma nei confronti
del Pil resterebbe fermo a 105,4%. Sarebbe quindi solo un aumento di
valore nominale. Mentre il deficit scenderebbe a 104.200 miliardi, quindi
al 6,1% del Pil, avvicinandosi sempre più al massimale comunitario.
E senza accorgercene siamo entrati in un altro scenario, quello dell'"eurocostrizione",
in cui è data priorità assoluta al risanamento dei conti
pubblici. Il governo, se ci riuscirà, potrà ritenersi
più che soddisfatto. Qualche problema lo avranno ancora una volta
i cittadini, sui quali si abbatterà una nuova e dura raffica
di stangate.
Ma tant'è. Se ci fosse giustizia, forse...
Sì, forse potremmo delineare un altro scenario. Quello in cui
un popolo insorge e caccia via i colpevoli. Ma naturalmente, come dice
Krugman, non c'è giustizia. E a pagare sarà invece la
gente comune, vittima sacrificale di un sistema ridotto a un colabrodo.
2 - Pericolo
di deindustrializzazione.
Tra baruffe politiche e crisi istituzionali, come va l'industria nel
nostro Paese?
Anche su questo argomento la confusione è di casa. Gli imprenditori
gridano alla catastrofe e propongono un "governo degli industriali".
Ma dal Palazzo giungono voci rassicuranti. Catastrofe non è.
Il sistema produttivo regge. Gli imprenditori facciano il proprio
mestiere, facciano andare meglio le proprie aziende. La politica è
tutt'altra cosa. Se poi crisi c'è, è così a livello
internazionale. L'Italia non è certo un caso a parte.
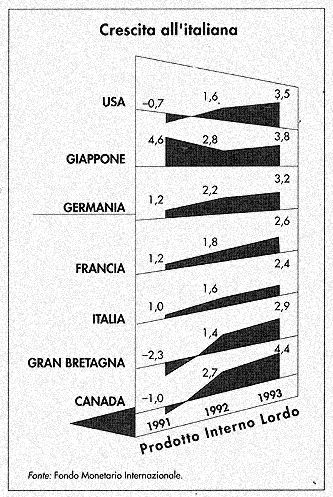
Il dissidio potrebbe sembrare insanabile, se a volte i ruoli non si
intersecassero o, addirittura, non si scambiassero. Così, politici
assumono posizioni dirigenziali nell'industria. Industriali vengono
eletti in Parlamento, diventando veri e propri politici. Il tutto
farebbe pensare alla possibilità di una maggiore comprensione,
da parte dei politici neo-imprenditori, dei problemi dell'industria
e, da parte degli industriali, divenuti politici, dei guai megagalattici
in cui versano i nostri governanti. In privato ci si potrebbe scambiare
qualche scusa. Ci si potrebbe mettere d'accordo per un contemperamento
di interessi. Ma c'è un'altra possibilità. Che così
facendo, si perdano di vista le questioni vere, il Paese, la sua economia,
la sua gente, i lavoratori.
La crisi comunque c'è. E si vede. I più pessimisti parlano
di pericolo di deindustrializzazione. L'apparato produttivo non è
più in grado di mantenere e, ancor meno, di conquistare quote
di mercato. I successi costruiti sulla flessibilità, sull'innovazione,
sulla scelta dei cosiddetti "mercati nicchia" appaiono difficilmente
ripetibili. Il made in Italy è incapace di sfornare prodotti
nuovi. Tutto il nuovo, dai telefoni cellulari agli apparecchi sanitari,
viene dall'estero.
La minore competitività non può più neppure essere
bilanciata col ricorso a svalutazioni periodiche, a causa dell'ingresso
italiano nella fascia stretta dello SME e dell'avvio del processo
di unificazione monetaria europea. L'inflazione sia pure in ribasso
supera di 3 o 4 punti quella dei nostri principali partners comunitari.
I settori ad alta tecnologia perdono sempre più posizioni.
Qui il divario rispetto ai concorrenti esteri è notevole, a
causa della debolezza nella ricerca e nell'innovazione. Una ricerca
a cui il nostro Paese destina solo l'1,3% del Pil e che è concentrata
per metà solo in cinque fra le imprese nazionali di maggiori
dimensioni. Le piccole e medie imprese restano invece ai margini del
processo innovativo.
Lo scorso anno Agnelli ammoniva: "di questo passo il problema
non sarà più il costo, ma il posto di lavoro".
E oggi le fabbriche licenziano o chiudono i battenti, come la Fiat
di Chivasso. Cassa integrazione e prepensionamento non bastano più
a compensare la perdita (definitiva) del posto di lavoro. Anche il
terziario, importantissimo settore-spugna per lavoratori eccedenti,
mostra segni di rallentamento. Servono nuovi ammortizzatori sociali.
Quello che stiamo descrivendo non è uno scenario orwelliano.
E' un sistema che sta scricchiolando e che rischia di sgretolarsi
tra i toni pacati dei dibattiti di palazzo. Attribuire sempre e comunque
i mali del nostro Paese ad effetti congiunturali, quindi transitori,
significa ancora una volta sviare l'attenzione dal nodo centrale di
una crisi che è tutta italiana.
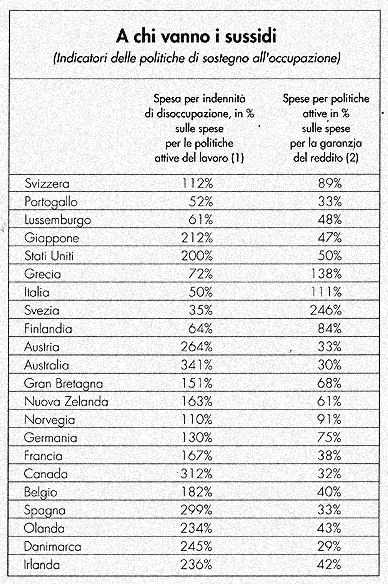
Il fantasma della recessione fa paura. Ma in Italia c'è dell'altro.
C'è il concorso dei fattori strutturali che indeboliscono l'apparato
produttivo e che richiedono una seria politica di rinnovamento generale.
E' chiaro ormai che le imprese si trovano di fronte ad una carenza
globale di capitali. Eppure l'Italia non è un Paese povero.
La gente risparmia più di quanto non accade in nazioni che
vanno meglio di noi. Ma sono risorse che, a causa della politica degli
alti tassi di interesse, vengono incanalate verso la copertura di
un debito pubblico di proporzioni gigantesche. Un circolo vizioso
che impedisce a quella ricchezza di raggiungere gli impieghi produttivi
e che, nel contempo, fa aumentare a dismisura il costo del denaro,
con ulteriore penalizzazione del sistema produttivo.
E' vero. Non è ancora un disastro. Ma se disastro ci sarà,
mai sarà stato così annunciato. La preoccupazione maggiore
serpeggia a Nord. E' qui che si verificano fenomeni inediti. Nell'industria
metalmeccanica si respira il clima della fine degli anni '70.
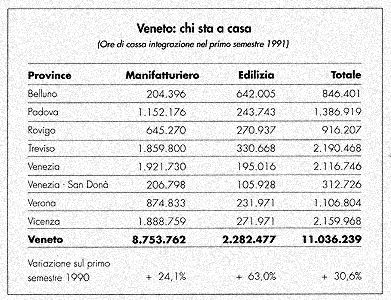
A Desio, in provincia di Milano, chiude l'Autobianchi, la fabbrica
che aveva fatto sorgere la città. La Fiat riduce i ritmi produttivi
e produce crisi su tutto l'indotto. Nella provincia di Torino si toccano
cifre record di cassa integrazione. L'Olivetti di Ivrea, dopo aver
già eliminato ben 5 mila dipendenti, è costretta ad
espellerne altri.
La Liguria e in particolare Genova devono fronteggiare gli esuberi
connessi alla cantieristica e alle produzioni militari. Il Veneto
e il Friuli cessano di essere il simbolo della piena occupazione.
A Vicenza barcolla anche il settore degli orafi, considerato inattaccabile
fino a poco tempo fa.
Tutto ciò, secondo Giuseppe De Rita, farà aumentare
il rancore che già serpeggia al Nord e che trova espressione
politica nelle Leghe.
In questo contesto, la colpa del Sud è quella di essere l'area
più assistita del Paese, in cui si genera sostanzialmente tutto
il debito pubblico italiano. E nonostante ciò, essa continua
ad essere anche l'area più arretrata. In realtà, il
degrado economico del Mezzogiorno non è altro che l'effetto
più lampante e perverso del circolo vizioso innescato nella
nostra società. Un circolo che privilegia l'afflusso di risorse
al settore pubblico, alle attività e ai servizi assistiti,
ai cosiddetti "ceti protetti". Un circolo che ha alimentato
la sperequazione, favorito la corruzione e operato una temibile saldatura
tra economia assistita ed economia criminale.
Ma la colpa del Sud è anche quella di essere diventato terra
fertile di conquista per le fabbriche del Nord. Eppure non si scende
al Sud perché si ha voglia di sottrarre quell'area dall'arretratezza
e dagli artigli mafiosi, come dovrebbe essere in presenza di una seria
politica industriale. Si scende al Sud perché c'è arretratezza,
quindi le condizioni migliori per sfruttare i lavoratori, imponendo
loro ritmi produttivi disumani. Esempio emblematico è quello
di Desio, dove la Fiat produce Panda e dove lo stabilimento è
destinato a chiudere perché i futuri modelli saranno prodotti
a Melfi, in Basilicata. Qui, in nome della mobilità, si violano
i più elementari diritti dell'uomo, imponendo il lavoro notturno
anche alle donne.
A pensarci bene, è proprio colpa del Sud?
3 - Gap tecnologico:
i mali della ricerca.
Negli anni '80, gli imprenditori italiani prendevano d'assalto i mercati
internazionali ed erano riconosciuti con l'appellativo di "nuovi
conquistatori". Dopo il primo e il secondo shock petrolifero,
infatti, era stato portato a termine un grande processo di ristrutturazione,
con massicci investimenti in automazione, innovazioni di processo
e recuperi di produttività secondi solo a quelli giapponesi.
Oggi di quei conquistatori resta ben poco. L'era del "made in
Italy" sembra ormai tramontata. Diminuiscono le invenzioni. Anche
la loro qualità risulta inferiore a quella dei giapponesi e
degli americani. E' quanto ci dicono le cifre. Dal 1990, l'Italia
occupa l'ultimo posto tra i Paesi più avanzati che hanno proceduto
a difendere le proprie innovazioni: 2.200 richieste di brevetto, rispetto
alle 3.744 della Gran Bretagna, alle 4.900 della Francia e alle 12.605
della Germania. Anche la Svizzera ci ha superato, segno evidente della
nostra inversione di rotta. Anche per quanto concerne la qualità
delle nostre invenzioni, prendendo come indicatore della validità
innovativa il numero medio di citazioni ricevute da ciascun brevetto,
i risultati non sono brillanti: tale numero è molto inferiore
a quello che si riscontra per i brevetti dei Paesi nostri concorrenti.
Altri segnali negativi giungono dal lato dell'export. Da un'analisi
condotta dal Cer, risulta che il rapporto tra specializzazione tecnologica
e specializzazione delle nostre esportazioni è molto basso.
Esiste cioè solo una debole correlazione tra i settori a forte
esportazione e i settori a maggiore forza tecnologica.
L'attività innovativa è concentrata soprattutto nei
settori declinanti, ossia in quei comparti dove il numero di invenzioni
brevettate tende a diminuire progressivamente nel tempo. I punti di
forza tecnologica coincidono, infatti, con i settori tradizionali,
quali il tessile, l'abbigliamento e le calzature. La sola eccezione
è rappresentata dal comparto delle macchine per l'industria,
l'unico vero baluardo dell'high-tech italiano.
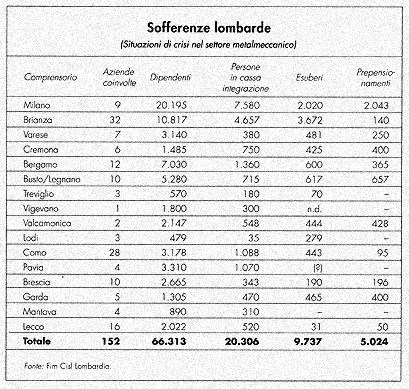
Questa specializzazione
tecnologica, limitata solo ai settori declinanti e a pochi prodotti,
non fa che aumentare la nostra debolezza rispetto alla concorrenza
estera, sia essa proveniente da Paesi tecnologicamente all'avanguardia,
come il Giappone, o da Paesi in via di sviluppo. Più precisamente,
secondo il Cer "l'Italia rischia di presentarsi sui mercati internazionali
con gli stessi prodotti offerti dai Paesi in via di sviluppo che operano
con costi molto più bassi. Inoltre potrebbe perdere le poche
posizioni di vantaggio che detiene nei comparti ad alta tecnologia".
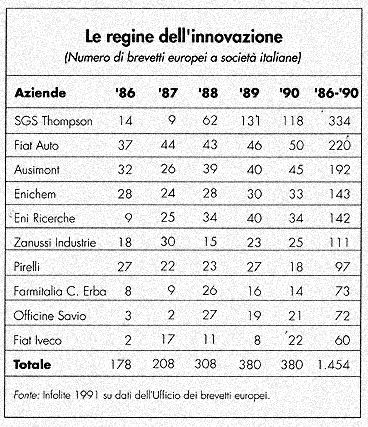
Infatti, "avere
i propri punti di forza in settori cosiddetti tradizionali non è
un male in sé. E' vero tuttavia che la possibilità di
aggiornare sempre queste produzioni si riduce con il passare del tempo".
Il problema, quindi, è di evitare che la domanda decrescente
di tecnologie e innovazioni che i settori tradizionali rivolgono ai
comparti high-tech, anziché essere compensata dalla domanda
proveniente da altri settori oggi con scarsa forza innovativa, come
quello dell'elettronica o quello delle telecomunicazioni, resti invece
l'unica in campo, a conferma della progressiva marginalizzazione tecnologica
del sistema industriale italiano.
Ancora una volta, sono le cifre a rivelare che la tendenza attuale
è proprio nel senso di un complessivo deterioramento della
nostra forza tecnologica: tra il '70 e il '74 erano solo cinque i
rami industriali caratterizzati da uno scarso livello tecnologico;
tra 1184 e 1187 il loro numero era aumentato a nove.
Nel 1988, il governo italiano ha destinato solo l'1,1% del Pil in
attività di ricerca, contro il 2,8% di Germania e Giappone,
il 2,7% degli Stati Uniti, il 2,3% di Francia e Gran Bretagna.
Il disinteresse del governo italiano verso questo problema è
notevole. Mentre Paesi come gli Stati Uniti e il Giappone si stanno
preparando ad affrontare la concorrenza globale investendo in nuovi
centri di ricerca all'interno e all'estero, in Italia si dimezzano
i fondi pubblici per la ricerca applicata e si continua a fare a meno
della politica industriale. Non esistono criteri nell'assegnazione
di fondi alle imprese. Non esiste selezione. Non esiste, appunto,
una politica industriale che individui gli obiettivi da perseguire
e i progetti da finanziare.
A ciò si aggiunge la svogliatezza e la scarsa propensione al
rinnovamento tecnologico dei nostri imprenditori. Tra il '79 e 1187
la spesa delle imprese in attività di ricerca è cresciuta
dallo 0,51% allo 0,84%, meno di quanto è cresciuta la spesa
che lo Stato ha destinato a questo settore. La spesa pubblica, cioè,
è divenuta sostitutiva e non aggiuntiva della spesa sostenuta
dai privati nella ricerca.
Secondo gli imprenditori la colpa resta pur sempre dello Stato che
non ha offerto incentivi adeguati a rendere meno costosa questa attività:
primo fra tutti, la detassazione degli utili destinati alla ricerca.
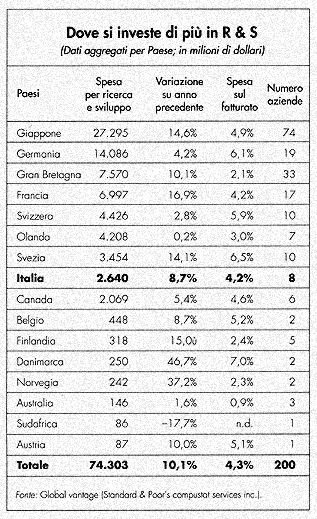
La validità
di questa critica non può, comunque, cancellare le colpe di
una classe imprenditoriale da sempre restìa a modificare in
senso innovativo la propria mentalità e a considerare la ricerca
per quello che veramente è: come, cioè, un fattore strategico
di sviluppo dell'impresa.
4 - I problemi
della piccola impresa.
La recessione, fin nei suoi primi sintomi, ha riportato a galla vecchi
problemi mai risolti. Tra questi, la preoccupante situazione in cui
versano le piccole e le medie imprese italiane, oggi impegnate in
una dura lotta per la sopravvivenza. Il rischio di essere escluse
dal mercato è infatti destinato ad aggravarsi a causa delle
nuove regole del gioco imposte dai gruppi oligopolistici internazionali
e della competizione sempre più agguerrita proveniente dai
Paesi dell'Est europeo.
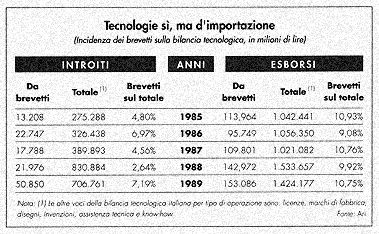
Dicevamo che si
tratta di un problema vecchio e mai risolto. In effetti, lo sviluppo
di questo tipo di struttura industriale ha sempre incontrato numerosi
limiti, anche nel periodo di sua massima espansione, caratterizzato
dallo slogan "piccolo è bello". In quel periodo,
una fitta rete di micro-aziende, altamente dinamiche, proliferò
e compensò la crisi in cui si erano imbattute le imprese di
grandi dimensioni, più rigide e quindi più lente ad
adeguarsi alle mutate esigenze del mercato. Quella struttura più
competitiva, opera dello spirito di inventiva di tecnici esperti,
formò un modello tutto italiano, appunto, il "made in
Italy", basato sulle innovazioni di processo e sulla fantasia
di stilisti e di disegnatori. Un modello che, a sua volta, per non
essere sorpassato dalla concorrenza estera, avrebbe dovuto "sorpassarsi
da sé", intraprendendo quel processo di rinnovamento strutturale
e produttivo oggi in atto nella maggior parte dei Paesi industrializzati.
Nel nuovo sistema di mercati aperti, infatti, il design e le innovazioni
di processo, cioè le innovazioni contenute nelle macchine,
cessano di costituire elementi di originalità e, quindi, di
differenziazione, su cui basare la forza competitiva della propria
impresa: i disegnatori prestano la propria opera anche all'estero
e le innovazioni di processo, per il loro basso costo di acquisizione,
sono ormai a disposizione di tutti i concorrenti.
Diverso è invece il discorso per le innovazioni di prodotto,
che non hanno un vero e proprio mercato di vendita. Per esse esiste
più spesso lo scambio, che quasi sempre si realizza tra imprese
che impegnano notevoli risorse finanziarie e intellettuali nelle attività
di ricerca. Da questo lavoro hanno tratto origine i c.d. "clubs
dell'innovazione", di cui è tipico esempio il farmaceutico.
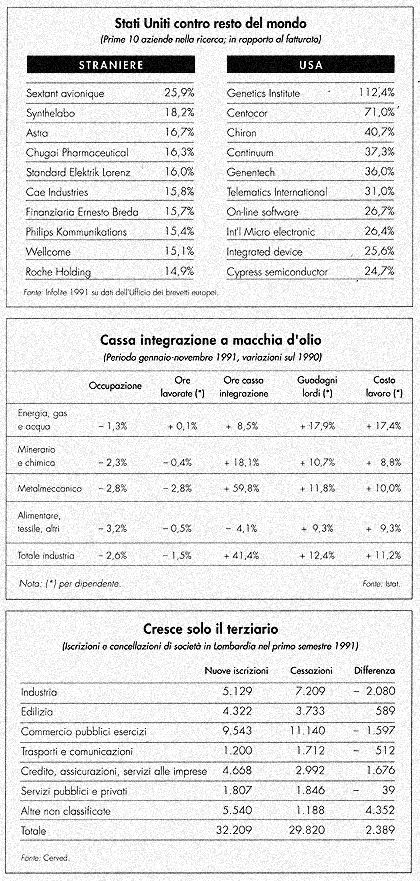
L'attuale lotta concorrenziale si svolge quindi su un diverso e più
alto livello, caratterizzato dalla revisione dei modelli organizzativi
e dal quale vengono automaticamente escluse le strategie obsolete
delle nostre aziende. Ci troviamo, cioè, in una nuova fase,
giudicata irreversibile, in cui per restare sul mercato occorre mettere
in campo strategie basate sull'innovazione di prodotto, sulla qualità
totale, sul consolidamento strutturale attraverso fusioni e joint
venture, su un sistema di finanziamenti che guardi più allo
sviluppo delle iniziative aziendali che all'esistenza di garanzie
reali.
E' con queste armi che i Paesi più industrializzati dovranno
affrontare i nuovi competitors dell'Est europeo, la cui concorrenza
si basa su produzioni a basso costo in settori tecnologicamente maturi,
come la chimica e la siderurgia. In questa fase, ripetiamo, le piccole
e medie imprese italiane, salvo poche eccezioni, non sono entrate
o sono entrate in modo passivo, in qualità di aziende acquisite.
Pochissime hanno puntato sull'innovazione di prodotto. E ciò
ha allungato le distanze che ci dividono dalle più dinamiche
imprese giapponesi, statunitensi e tedesche, soprattutto nei settori
in cui sono impiegate le nuove tecnologie elettroniche.
5 - Emergenza
occupazione.
Stando alle previsioni, il numero di posti in meno tra la fine di
quest'anno e l'inizio del prossimo saranno circa 300 mila. La tendenza
al calo degli occupati non accenna quindi ad esaurirsi e rischia di
distruggere il patrimonio occupazionale a cui l'economia italiana
ha dato vita negli anni di maggiore sviluppo. Questo pericolo non
ha ancora assunto, almeno ufficialmente, i caratteri dell'emergenza.
Dai dati aggregati, anzi, risulta che l'occupazione è in crescita.
Tra il luglio del '90 e il luglio del '91, secondo l'Istat, il numero
di occupati è aumentato di 165 mila unità, per un totale
di 21,8 milioni. Nello stesso periodo, il tasso di disoccupazione
è sceso dall'11,3% al 10,6%. L'ottimismo invece svanisce allorché
si guardi agli andamenti per grandi settori. Dati decisamente negativi
giungono dalla grande industria. Nel novembre 1991, l'indice dell'occupazione
nelle imprese industriali con più di 500 dipendenti, calcolato
con base 1988=100, è stato pari al 94,6, con un calo dello
0,2% rispetto al mese precedente e del 3,1% rispetto al novembre del
'90.
Situazione particolarmente negativa nella siderurgia, che ha subito
contrazioni occupazionali di entità pari al 13,3%. Seguono
il tessile e l'abbigliamento, con tagli dell'8,4%. In difficoltà
anche i settori del legno, della carta e della gomma, i cui livelli
occupazionali sono stati ridotti del 6%.
Tra novembre 190 e novembre 191, i maggiori cali occupazionali si
sono verificati nell'industria dei beni di investimento (-3,7%). Contrazioni
di minore entità si sono registrate nell'industria dei beni
di consumo (-2,1%), seguita da quella dei beni intermedi (-2,5%).
La flessione ha investito soprattutto la categoria degli operai e
degli apprendisti (-4%), mentre è stata più contenuta
per quella degli impiegati e intermedi (-1,2%). Per l'industria nel
suo insieme, nel periodo gennaio-novembre 191, l'occupazione alle
dipendenze ha subito un'erosione del 2,6% rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente.
Anche nella piccola impresa la situazione sta inesorabilmente precipitando.
Nei primi sette mesi del '91, i tagli personale sono stati del 2,5%.
Una percentuale che rischia di aumentare. La nuova fase in cui è
entrato l'intero apparato industriale, infatti, richiede che si intraprendano
strategie basate sull'innovazione di prodotto, per poter recuperare
margini di profitto. Le piccole imprese non ne hanno le capacità
e per sopravvivere cercheranno di ridurre al minimo i costi di produzione.
In particolare, contraendo l'occupazione.
Le richieste di riduzione del personale sono numerosissime e provengono
soprattutto dalla grande industria. Tra il '91 e il '92, i prepensionamenti
certi saranno più di 36 mila, ma è un numero destinato
a lievitare, considerato l'aumento incalzante delle richieste. Né
si può sperare di ricorrere sempre a questo rimedio, per contrarre
i livelli occupazionali. Il prepensionamento, infatti, ha un alto
costo, che si può quantificare in circa 100 milioni a lavoratore
per cinque anni.
L'altro rimedio è, da molti anni a questa parte, la Cassa integrazione.
Con una novità. In base alla legge del 27 luglio 1991 n. 223,
i lavoratori potranno usufruire per un massimo di 12 mesi della Cig
ordinaria e per 24 mesi (prorogabili due volte) della Cig straordinaria.
Dopo quel periodo non avranno più alcuna garanzia di salario.
Saranno iscritti in apposite liste e dovranno cercarsi un altro lavoro.
C'è chi spera nel terziario, quale settore in grado di riassorbire
l'ondata dei nuovi disoccupati. C'è chi guarda al pubblico
impiego e all'elasticità del blocco delle assunzioni statali.
Ma è chiaro che si tratta di rimedi del tutto inadeguati rispetto
all'entità che rischia di assumere il fenomeno.
Secondo gli imprenditori, solo una riduzione del costo del lavoro
potrebbe consentire alle imprese di mantenere invariati i livelli
di occupazione esistenti.
I sindacati sono disarmati, ma ritengono che il problema debba essere
affrontato su altre basi. E' la politica degli incentivi che va cambiata.
Bisognerebbe smetterla con i finanziamenti a pioggia e tornare ad
una politica industriale molto più selettiva.
|