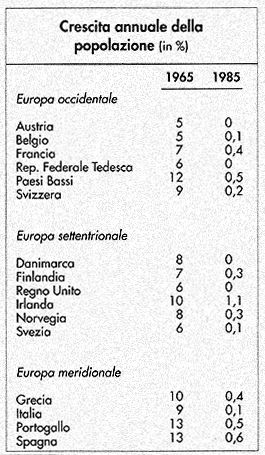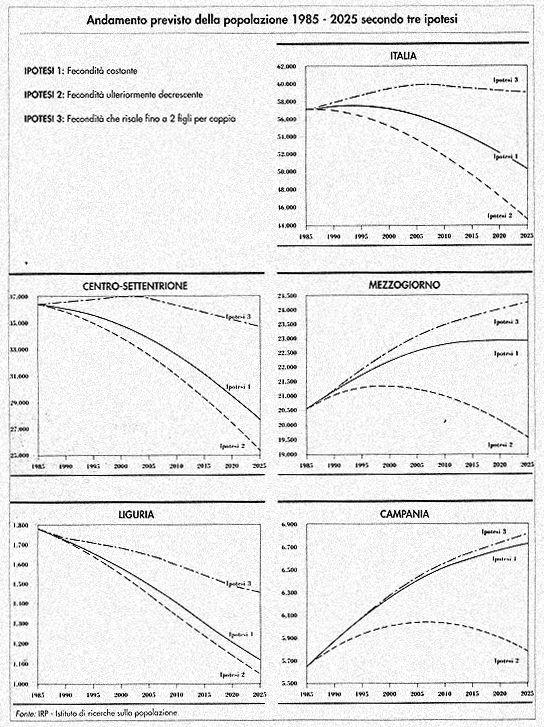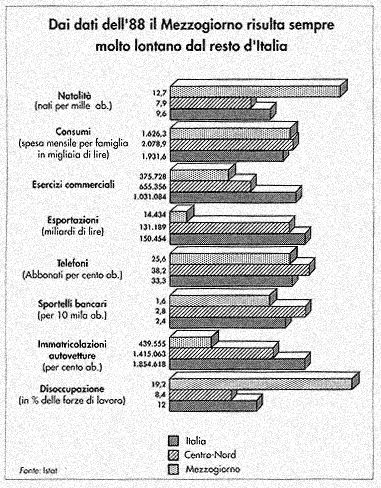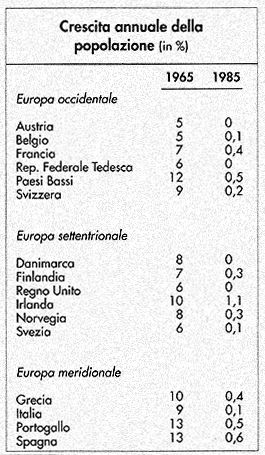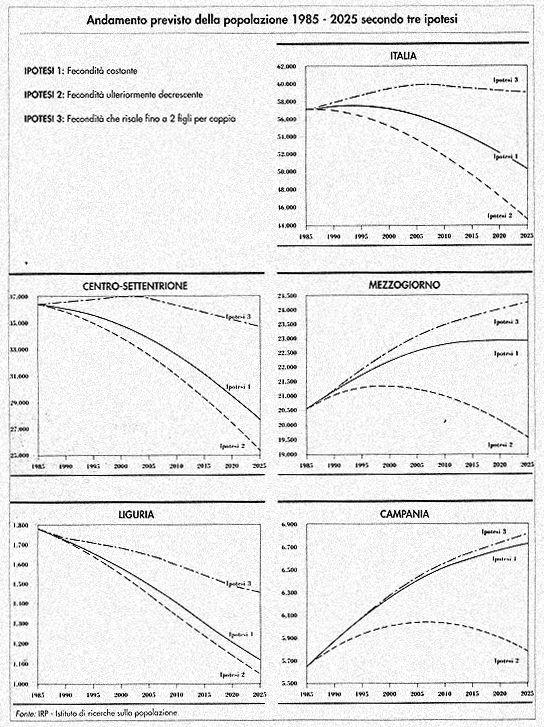E' stato scritto
che il meridionalismo liberale non ha avuto vita facile negli ultimi
quarant'anni di storia italiana. Fino a un decennio fa, o poco meno,
la cultura marxista, largamente egemone, aveva negato ogni legittimità
a un meridionalismo di questo tipo. Il suo principale ispiratore,
infatti, non era Benedetto Croce? Ebbene, Croce aveva negato l'esistenza
stessa di una questione meridionale e, tessendo nella sua Storia d'Italia
l'apologia del modo in cui si era realizzata l'unità italiana,
si era precluso ogni possibilità di individuare le tare storiche
del Risorgimento: prima di tutto l'incapacità delle forze risorgimentali
di realizzare una rivoluzione agraria. Se la questione meridionale
era vecchia di secoli, il nuovo Stato unitario l'aveva però
non solo ereditata, ma - per così dire - suggellata, in quanto
aveva definitivamente omologato quella struttura economico-sociale
asfittica e immobile, basata sul latifondo, che era alla radice dell'arretratezza
meridionale. Perciò il meridionalismo liberale non possedeva
strumenti per affrontare in modo corretto e incisivo il tremendo problema
del Mezzogiorno. Questi strumenti si trovavano in parte in Gaetano
Salvemini, ma soprattutto in Antonio Gramsci. Solo la cultura di ispirazione
socialista e marxista poteva farsi carico di un'efficace e incisiva
battaglia meridionalista.
La parzialità (e unilateralità) di questo schema risultavano
già dal fatto che una delle riviste meridionaliste più
serie ed impegnate, Nord e Sud, fondata da Francesco Compagna nel
1954, era di ispirazione liberale. Intorno a questa rivista si raccoglieva
un gruppo di studiosi capaci di analisi puntuali e precise, di efficaci
proposte socio-economiche e politiche, capaci, in altre parole, di
dare un contributo di prim'ordine alla battaglia meridionalista. Segno
che la matrice liberale, dalla quale il gruppo di Nord e Sud rampollava,
non era quel "cane morto" che molti pretendevano fosse.
Quest'immagine di fecondità e di forza si ricava, fra l'altro,
dal volume di Laterza che raccoglie importanti saggi e articoli di
Compagna, tutti di argomento meridionalistico, dai quali emergono
la vasta cultura, la notevolissima capacità di analisi, la
profonda conoscenza della storia e della realtà meridionale
di uno dei maggiori uomini politici e intellettuali contemporanei.
In una prima parte, dedicata alle matrici ideali del meridionalismo
liberale. Compagna rende giustizia a Croce, smontando le principali
deformazioni di cui il filosofo napoletano è stato oggetto.
Croce non ha mai disconosciuto l'esistenza di una questione meridionale
(e in varie sedi egli ha sottolineato le benemerenze politiche acquistate
dai meridionalisti, con il loro impegno "a procurarsi una esatta
conoscenza della dura realtà; e a guardarla in volto con dolore,
ma con coraggio", come ebbe a scrivere una volta); e se ha polemizzato
spesso con i meridionalisti, ciò non è stato mai rispetto
ai problemi concreti che essi venivano proponendo nel dibattito politico
italiano, quello della riforma tributaria (Giustino Fortunato), come
quello delle tariffe doganali (Antonio De Viti De Marco), non meno
di quello più generale delle classi dirigenti (Guido Dorso).
La vigilanza di Croce si è esercitata piuttosto sistematicamente
nei confronti delle "illazioni arbitrarie" cui spesso i
meridionalisti finivano per abbandonarsi, con pregiudizio dei problemi
stessi che essi volevano risolvere: dal razzismo dei positivisti al
pessimismo in cui sfociava il determinismo naturalista di Giustino
Fortunato che, di sconforto in sconforto, poteva spingere al più
desolante disfattismo politico nei confronti degli ideali liberali;
fino allo schematismo astratto che derivava dalle formule come "conquista
regia" e "blocco industriale-agrario" di Gobetti e
di Dorso, e anche di Salvemini, formule non più diverse da
quelle di Oriani e di Missiroli; per non parlare poi dei miti politici
di destra e di sinistra, dal colonialismo borghese senza capitali
da investire alla rivoluzione contadina senza terra da distribuire.
Inoltre Croce ebbe il merito di sottolineare con forza che la questione
meridionale non avrebbe potuto essere affrontata in modo efficace
se non si fossero prima formate nello stesso Mezzogiorno nuove e robuste
classi dirigenti, culturali e politiche.
Un posto di rilievo nell'elaborazione del meridionalismo liberale
spetta a Giovanni Amendola, il quale, in un importante discorso pronunciato
nel 1920, disse che "questo problema del Mezzogiorno è
soprattutto, prima ancora di essere un problema giuridico riguardante
lo spezzettamento del latifondo, un problema di esistenza di impianti
sociali, e cioè strade, acqua, case, comunicazioni in genere,
tutto ciò che occorre per l'attivamento della vita sociale,
tutto quello senza cui è impossibile concepire lo sviluppo
di una civiltà moderna, di una cultura, di una moralità
moderna". Un problema di tale mole poteva essere affrontato naturalmente
solo dallo Stato: ecco perché la creazione dello Stato unitario,
lungi dal costituire l'omologazione dell'arretratezza meridionale,
costituiva invece la premessa essenziale per affrontarla e combatterla.
Ponendo con forza il problema delle infrastrutture dello sviluppo
economico e civile, e ponendo altresì il problema degli ingenti
mezzi necessari per realizzarle, e della concentrazione di questi
mezzi in un organo centrale, Amendola aveva elaborato il nocciolo
di un pensiero nuovo e diverso sia rispetto alle impostazioni libero-scambiste
di De Viti De Marco e di Fortunato, sia rispetto al problemismo salveminiano.
In altre parole, e Compagna lo riconobbe, Amendola aveva anticipato
le linee generali di quello che sarebbe stato nel secondo dopoguerra
l'intervento straordinario e aggiuntivo dello Stato per lo sviluppo
economico e civile del Mezzogiorno, al quale avrebbero poi dato un
contributo di idee uomini come La Malfa, Rossi Doria e Saraceno.
Nelle pagine di Compagna, il problema della pre-industrializzazione
del Mezzogiorno ha un rilievo fortissimo, nella convinzione che la
via per il riscatto di questa regione, o di questo continente, per
il suo trasferimento a livelli europei, è da cercare non solo
nella creazione (là dove la geografia lo consente) di un'agricoltura
moderna, ma anche e soprattutto dell'industrializzazione. Solo l'industrializzazione,
infatti, può far sorgere quei nuovi centri cittadini capaci,
in primo luogo, di decongestionare le grandi città gremite
di un sottoproletariato miserabile e di una piccola borghesia depressa;
e poi capaci di sviluppare un nuovo tessuto civile, una nuova mentalità,
nuove classi dirigenti, politiche e culturali.
Lungo questo cammino sono stati conseguiti indubbi successi, ma ci
sono state anche, come tutti sanno, grandi sconfitte. Compagna individuava
i motivi delle sconfitte nel fatto che "si è trascurato
e si continua a trascurare il problema dei quadri della politica meridionalista".
E che cosa è accaduto ai nostri giorni? Quale bilancio fare?
E' tempo di abolire la Cassa per il Mezzogiorno, si disse, e di creare
al suo posto un ente più moderno, più agile, che sia
in sintonia con i tempi, con i ritmi, con le esigenze del nuovo Mezzogiorno.
In realtà, la vecchia Cassa era ormai imprigionata in antiquate
strutture burocratiche, avvolta in pastoie procedurali vischiosissime.
Nel bene e nel male, il suo compito appariva a tutti esaurito. Quelli
in cui fu ideata e varata erano stati giorni di passione: fortemente
l'aveva voluta De Gasperi (il nome di "Cassa" era stato
suggerito da Menichella); e altrettanto fortemente era stata osteggiata
dalle forze di sinistra e dai gruppi laici, che la consideravano uno
strumento di trasformismo che avrebbe mortificato le forze creative
meridionali. L'obiettivo degasperiano non era avulso dalla realtà
politica e sociale del tempo. Di fronte ai contadini che reclamavano
il possesso della terra, quando questa "tremava" per le
occupazioni massicce del latifondo, nell'immediato dopoguerra, si
pensò a una riforma agraria che facesse calare la febbre, e
ad una serie di interventi straordinari che portasse sulle campagne
alcuni servizi essenziali che consentissero la sopravvivenza.
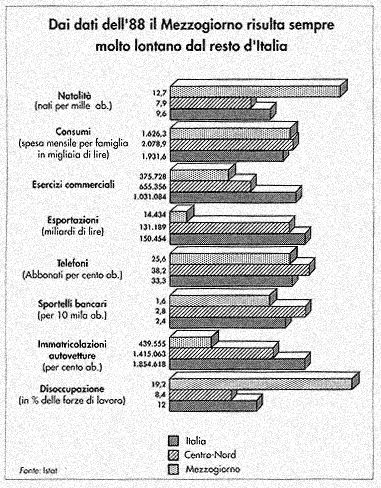
Si sa quel che poi accadde. Si frantumarono le periferie di alcuni
latifondi, prive comunque di acqua, di energia elettrica, persino
di vie di comunicazione. I contadini rimasero isolati, in un territorio
desolato e in non pochi casi persino ostile. Dotata di un capitale
quale mai era stato destinato al Sud, la Cassa intervenne nel campo
delle bonifiche e delle sistemazioni, con cantieri Via pioggia"
che, come si scrisse, divisero un sudario in mille brandelli. Inutili
le battaglie di chi avrebbe voluto comunicazioni, scuole professionali
e di formazione, trasporti, ritenendo superata l'ideologia della "terra
ai contadini" e destinata al fallimento l'economia agricola con
colture estensive. Nel giro di qualche anno, i poderi degli assegnatari
incominciarono ad essere abbandonati. I contadini presero il treno
ed emigrarono in massa. Dapprima nell'Italia del Nord, poi in Europa
occidentale. Furono colti di sorpresa tutti: Cassa, politici, economisti,
meridionalisti. In pieno boom economico, emigrava un meridionale ogni
minuto primo.
La Cassa si rifinanziò, aggiornandosi. Nacquero i progetti
per i poli e per le aree di sviluppo industriale; poi nacquero i "progetti
speciali" che riguardavano più regioni. Ma il grande decollo,
auspicato negli anni Cinquanta, non venne. Si riaccesero le polemiche,
del resto mai venute meno. Alla fine nacque il nuovo organismo: un
Dipartimento dal quale dipende un'Agenzia, che a sua volta è
collegata con una serie di enti e di sub-enti. Tutti alle prese con
i problemi del Mezzogiorno. E tutti gestiti secondo la logica della
spartizione politica, che ha creato un equilibrio così perfetto
da tradursi nella più perfetta inerzia operativa.
Alle regioni - e doveva essere questa la più cospicua novità
della nuova legge sul Mezzogiorno - erano affidati poteri straordinari:
dalla formulazione di programmi alla loro realizzazione. Ma poiché
le regioni non sono assolutamente in grado di assolvere a compiti
così impegnativi, ne è risultata una situazione catastrofica
e allarmante: su 2.500 progetti inviati dalle regioni meridionali
al Dipartimento, per un importo complessivo di 27.000 miliardi di
lire, "il venti per cento - causa le gravi carenze riscontrate
nella documentazione - non ha superato l'esame, e per il sessantacinque
per cento degli importi il giudizio è sospeso in attesa di
integrazioni nella documentazione".
Dove e come, dunque, spendere 120.000 miliardi di lire, spesa prevista
dalla nuova legge? Saranno favoriti gli infrastrutturalisti, sostenitori
della tesi che occorre prima ripulire e preparare il territorio meridionale,
creando poi le condizioni ottimali per un decollo economico integrato?
Oppure saranno privilegiati gli industrialisti, i quali non hanno
abbandonato l'idea di una massiccia e rapida industrializzazione?
Forse non prevarrà nessuna delle due parti. La tesi prevalente,
infatti, è che il fiume di miliardi deve ancora una volta essere
diviso in migliaia di piccoli ruscelli, che finiranno per placare
almeno in parte la fame di interventi pubblici dei titolari di collegi
elettorali. La storia non cambia.
In mancanza di ogni seria programmazione, le nuove iniziative tardano
a partire. E molte di quelle che partono non sempre giungono a destinazione.
Ogni anno - conferma l'istituto Tagliacarne - nascono nel nostro Paese
346.000 nuove imprese. Alcune vengono alla luce robuste e rigogliose,
soprattutto in vaste aree del Nord, in Toscana, nelle Marche e in
Emilia-Romagna.
Il tasso di mortalità infantile cresce, com'è ormai
tradizione, a mano a mano che si scende verso la Sicilia e le aree
dell'anemia mediterranea, con l'eccezione di qualche rara isola, riscontrabile
in Puglia e nelle fasce settentrionali dell'Abruzzo. Il giudizio degli
esperti è pressoché unanime: le nuove imprese nascono
e crescono male perché mancano i servizi essenziali, le telecomunicazioni,
l'energia, i trasporti, le scuole di formazione professionale. Problemi
noti già alcuni decenni fa.
La grande industria, in realtà, ha seguito con una certa distrazione
la difficile nascita della nuova legge sul Mezzogiorno. Ovviamente,
essa è interessatissima a cogliere tutti i vantaggi offerti
da quella legge e ad approfittare, come al solito, di ogni provvidenza,
incentivo, esenzione fiscale, offerti dal legislatore. In questo senso,
lo abbiamo rilevato da tempo, le leggi sul Mezzogiorno hanno praticamente
aiutato più il Nord che il Sud. Ma gli industriali italiani
hanno capito che in vista del 1993 la discesa verso il Sud è
indispensabile se si vogliono allontanare pericolosi concorrenti.
Così, quasi in sordina, la Fiat ha collocato nel Mezzogiorno
una trentina di impianti, che vanno dal settore automobilistico alla
componentistica, dalle telecomunicazioni all'ingegneria civile.
L'iniezione di uomini, di management e di tecnologia dal Nord verso
il Sud è stata in alcuni casi massiccia. In cifre, ad esempio,
la Fiat occupa nelle regioni meridionali cinquantamila persone - il
22 per cento del totale nazionale - con diciottomila addetti in Campania
e importanti teste di ponte a Termoli, a Cassino, in Salento e in
Sicilia. E ha avuto parecchi imitatori.
Vecchi e pigri clienti del Sud - la Pirelli e la Montedison - pensano
a massicci investimenti in settori strategici come le fibre di carbonio
e la trasmissione di energia. La fila è lunga. Antichi e nuovi
imprenditori, da De Benedetti a Ferrero, da Tanzi a Barilla, si apprestano
a varcare la linea del Garigliano.
Per la prima volta, dunque, stiamo forse assistendo all'avveramento
del miracolo invocato da tutti i meridionalisti? Non è così.
L'invocato indotto, l'intreccio tra i grandi poli industriali e le
piccole e medie imprese è ancora di là da venire. L'osmosi
tanto attesa non si è verificata.
Le sette grandi industrie italiane (Fiat, Pirelli, Barilla, Ferrero,
Montedison, Olivetti, Ferruzzi) che hanno investito molte migliaia
di miliardi nel Sud hanno dato occupazione a non più di ottantamila
persone. I dati sono agevolmente verificabili.
Ci si chiede: che fare? Questa situazione è immodificabile?
Per molti imprenditori lo è. Grandi industrie come la Fiat
o la Olivetti - si commenta - possono anche non preoccuparsi se nel
Mezzogiorno le infrastrutture sono inesistenti o inadeguate. Creeranno
servizi alternativi e troveranno poi il modo di rivalersi con lo Stato.
Ma come può un piccolo industriale investire a Sud quando una
lettera dalla Sicilia, dalla Calabria o dalla Basilicata può
impiegare anche venti giorni, quando lo stretto di Messina è
intasato per sei mesi all'anno, quando le merci per risalire la penisola
debbono viaggiare su ferrovie che sono fra le più arretrate
d'Europa, quando per ottenere l'allacciamento di un telex bisogna
far ricorso alla raccomandazione di un ministro?
I più sensibili avvertono: attenzione, se il Mezzogiorno non
ammodernerà al più presto le sue infrastrutture, l'Italia
perderà un'occasione storica. Ma non è stato già
detto e ripetuto fino alla schizofrenia? Mentre noi stiamo fermi,
i nostri partners europei si stanno aggiornando. Basti pensare che
quando sardi ultimato il passaggio sotto la Manica, un sistema integrato
di ferrovie ad altissima velocità collegherà Parigi,
Londra, Bruxelles, Amsterdam, Losanna, Berlino. Il rischio, a quel
punto, è che non riusciremo a tenere il passo con il Nord-Europa:
il Mezzogiorno sarà diviso definitivamente da un fossato incolmabile.
Questo compito, essenziale e prioritario, di ammodernare le regioni
meridionali deve essere assunto dallo Stato. E' lo Stato che deve
ricostruire quel circolo virtuoso che oggi manca all'economia meridionale
in settori strategici come l'energia, i trasporti, le telecomunicazioni,
il turismo. I servizi sono vitali, lo aveva detto Manlio Rossi Doria
quarant'anni fa.
Tante idee, altrettanti buoni propositi. Ma c'è chi sostiene
che non sono i quattrini e i progetti che mancano, bensì la
buona amministrazione. Ci sono nel Mezzogiorno assetato decine di
dighe cominciate e non ultimate. Ci sono da decenni. Ci sarebbero,
secondo una denuncia recente, oltre 43 mila progetti in corso, tre
quarti dei quali avviati ma non condotti a termine. C'è un
patrimonio turistico e artistico negletto e saccheggiato, ma scarsamente
utilizzato come fonte di lavoro e di reddito. Dove sarebbe indispensabile
la presenza di uomini di scienza e di cultura, con capacità
ed esperienza, ci sono troppo spesso uomini lottizzati, prescelti
solo in virtù di uno schieramento politico. In questo senso,
soprattutto, occorre bonificare, materialmente e moralmente, il Mezzogiorno.
E' questo l'appello di molti meridionalisti. Intorno alle ingenti
risorse destinate al Sud - sostiene Giuseppe Galasso - si è
venuta a costituire una rete generale di valvassori e di valvassini,
una serie di incrostazioni di potere di gruppi e di gruppetti che
agiscono nei partiti. Secondo Galasso, Roma deve rinunciare alla logica
del piatto di lenticchie, al baratto tra l'assistenzialismo clientelistico
al Mezzogiorno e la ben più sostanziale protezione degli interessi
nel resto del Paese.
Si riapre così l'antica questione Nord-Sud la polemica che
a cavallo del secolo contrappose, nel momento più polemico
Gaetano Salvemini al "partito del malgoverno".
A proposito
di blocco del potere
Sfoltire gli
enti a sud
Giuseppe Galasso
A leggere le cronache
parlamentari, l'audizione dei responsabili degli enti collegati alla
politica per il Mezzogiorno presso la competente Commissione Bicamerale
non sembra offrire elementi di fondo davvero nuovi che possano servire
da criteri di un diverso orientamento in materia. Si sa che tra quei
vari enti alcuni appaiono meglio condotti di altri, qualcuno appare
addirittura in letargo, la maggior parte non riesce a trovare né
la via per soddisfare appieno alle esigenze a cui la legge li destina
né un sentiero diverso, suscettibile di essere percorso all'insegna
di un disegno fortemente caratterizzato. Non è nemmeno da vedere
in ciò tutto e soltanto un demerito dei responsabili di quegli
enti.
Fortemente incide su di essi la complessità delle procedure,
a cui esse debbono ottemperare. Si rivela appieno, in tali procedure,
la contraddizione di un versante cospicuo della politica per il Mezzogiorno.
Da un lato, essa è una politica che dovrebbe seguire criteri
estremamente dinamici e operativi, una linea di attiva e costante
iniziativa, gli obiettivi di un'azione duttile e creativa. Dall'altro
lato, deve inquadrarsi senza eccezioni nelle norme della procedura
amministrativa pubblica, a garanzia e tutela dell'impegno anche finanziario
che la parte pubblica si sostiene per il Sud. Le due esigenze dinamismo
economico dell'iniziativa e garantismo amministrativo dei modi di
realizzare l'iniziativa stessa sono, inoltre, potenziate nella loro
contrapposizione dal fatto che gli enti di cui parliamo non hanno
neppure una compiuta autonomia: debbono dar conto dei loro bilanci
e della loro gestione anche, diciamo così, in corso d'opera.
Detto questo, bisogna però dire anche altro. Non si può
tacere ad esempio che le amministrazioni degli enti di cui parliamo
sono luogo di convergenza di forti interessi politici e di partito,
e lo sono anche nel senso di costituire una specie di ufficio di collocamento
di quadri politici e di partito.
La professionalità specifica (amministrativa, imprenditoriale,
tecnica) è un elemento subordinato: può capitare che
vi sia, e allora tanto meglio (e, infatti, molte volte c'è),
ma può anche capitare che non vi sia, e un tale caso, per lo
meno altrettanto frequente, dovrebbe andar bene lo stesso: invece,
com'è naturale, non va bene affatto, e se ne vedono i risultati.
Questa - si dirà - non è un'osservazione che riguardi
solo gli enti meridionalistici, bensì l'intera gestione delle
nomine pubbliche in Italia, e purtroppo è vero. Ma si dovrà
riconoscere senza remore che, quando ciò accade in settori
specialistici e tecnico-professionali particolari, con fini così
caratterizzati come quelli dello sviluppo di una vasta area, le conseguenze
sono ancora peggiori. Né si può tacere l'impressione
di una accentuata dispersione dell'intervento a cui si mira attraverso
gli enti, e ciò a causa di un doppio inconveniente. Da un lato,
si è agito, consapevolmente o inconsapevolmente, come se l'intervento
straordinario dovesse avere in ogni suo aspetto tecnico e settoriale
una gestione diretta. In tal modo il valore di sollecitazione, di
incentivo, di cornice politico-amministrativa per l'induzione di un
processo di sviluppo ha visto attenuarsi progressivamente la sua capacità
di spinta (già tanto problematica per tanti altri motivi) e
ha portato a una bardatura pubblica tanto ingombrante quanto poco
efficace nel determinare la spinta voluta.
Dall'altro lato, pressoché per ogni aspetto o settore di interesse
di una politica dello sviluppo e di attuazione dell'intervento straordinario
nel Mezzogiorno, si è subito pensato a costituire una nuova
società o un nuovo ente, più o meno sub-collegato degli
enti originariamente previsti. Quasi che costituire una società
significasse soddisfare al bisogno economico-sociale che si credeva
di avere individuato, sempre che si trattasse di soddisfare a un tale
bisogno e non di servire a disegni di altra natura. Queste considerazioni
vanno al di là - come si vede - della fisionomia e della conduzione
dei singoli enti in questione. Esse sono mosse anche da una constatazione
tanto sgradevole quanto incontestabile: nel loro complesso, i risultati
degli enti in anni e anni di attività appaiono, a dir poco,
alquanto deludenti e, comunque, lontani da quel che si pensava dovessero
essere. La Fime è una delle meglio condotte, e, per di più,
anche nettamente attiva nel suo bilancio, con un vertice di sicuro
valore, vanta appena - quale banca d'affari - un complesso di partecipazioni
per una settantina di miliardi.Il Formez, con un vertice anch'esso
di sicura dignità, è ancora lontano dal diventare quel
motore
della formazione nel Mezzogiorno, che pure è nella sua aspirazione
di essere. Di altri casi non parliamo, e tanto meno parliamo di qualche
caso di amministrazione assai discussa.
Che concluderne? il ministro per il Mezzogiorno ha pubblicamente espresso
il suo intento di mettere ordine in questo settore. E' un intento
da approvare e da appoggiare senza riserve. Personalmente resto fermamente
convinto di una tesi altre volte sostenuta: che cioè è
necessario sfoltire le "selve" degli enti e sub-enti allignata
intorno alla politica per il Mezzogiorno.
Non si dovrebbe Faticare molto a riconoscere che quella "selva"
ha determinato ulteriori, grosse incrostazioni di questa politica.
Di questa politica si conviene ora di leggere uno degli aspetti più
negativi e paralizzanti nella interpretazione che una parte rilevante
della classe politico-amministrativa del Mezzogiorno ne ha operato
ai fini del suo potere in loco e a Roma. Si conviene ora di ravvisare
qui un nuovo "blocco di potere" da rimuovere, come altri
precedenti, se si vuole determinare una condizione in alto senso "politica",
indispensabile per lo sviluppo del Sud.
Gli enti in questione rientrano, di fatto, largamente nella "strategia
spontanea" del "blocco del potere", di cui si lamenta
la formazione. Una risposta adeguata - per quel che li riguarda -
può essere una loro riduzione a pochissimi" casi (la formazione,
l'assistenza il credito tipo banca d'affari), accompagnata da un forte
potenziamento della loro autonomia, professionalità, disponibilità
di risorse, con figurazione procedurale. E' un chiedere troppo?
Demografia
1991: anno zero
E poi Italia
meridionalizzata
Flavio Albini
Sarà il
1991 l'anno zero dal punto di vista demografico per il nostro Paese
e fra trent'anni, cioè nel 2018, il numero degli italiani dovrebbe
diminuire di poco più di cinque milioni. Il calo interesserà
le aree del Centro-Nord, mentre quelle del Sud e dell'Italia insulare
avranno un aumento della popolazione. Questi sono soltanto alcuni
dei dati resi noti nelle proiezioni dell'Istituto centrale di Statistica
(Istat), appunto fino all'anno 2018.
La prima considerazione da fare è che per quell'epoca l'Italia
settentrionale sarà abitata soprattutto da persone anziane.
L'incremento demografico che riguarderà quattro regioni del
Sud (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) potrebbe riprodurre il
fenomeno dell'emigrazione del primo dopoguerra, spesso materia di
letteratura e di cinema, come nel film Rocco e i suoi fratelli.
L'eccedenza demografica del Mezzogiorno di quasi due milioni e mezzo
di persone, infatti, dovrebbe far rivivere l'esperienza dei "treni
della speranza", presumibilmente formati da carrozze confortevoli
e locomotori superveloci, e non più, come allora, da superate
vetture di terza classe, dai sedili di legno. Mentre le quattro regioni
ricordate aumenteranno la popolazione, altre tre (Molise, Basilicata
e Sardegna) dovrebbero mantenerla pressoché costante sui livelli
attuali.
Allo stato, l'Italia è ai primissimi posti nella graduatoria
dei Paesi con il più basso indice di natalità, insieme
con la Danimarca, con la Repubblica Federale Tedesca e con l'Olanda.
Il processo di avvicinamento alla crescita zero, in effetti, incominciò
a partire dagli anni Settanta. Il piccolo boom dell'incremento demografico
si ebbe nel 1964, con un milione di nati. Natalità che, nello
scorso anno, è scesa di mezzo milione. La vera e propria caduta
ha interessato in modo preoccupante il periodo fra il 1978 e il 1986.
Una tendenza alla stabilizzazione comunque ha evitato fino a questo
momento un temuto punto zero. Il pericolo, però, non è
svanito, ma si è soltanto allontanato e, secondo l'Istat, dovrebbe
essere raggiunto nel 1991. Un incremento poco probabile ma non impossibile
della natività servirebbe soltanto a ritardare l'evento fino
al 1997.
L'Istat, per questo, ha indicato due prospettive. La prima si colloca
nell'ipotesi che prosegua l'attuale andamento con una natalità
decrescente: in questo caso, alla fine del secolo, gli italiani saranno
56 milioni e 900 mila rispetto ai 57 milioni e 400 mila di oggi. La
seconda prospettiva considera invece un arresto del fenomeno e, in
questo caso, la crescita zero cadrebbe sei anni più tardi,
cioè nel 1997. In tutti e due i casi, però, la diminuzione
della popolazione toccherebbe nel 2018, le cifre già indicate.
Le considerazioni sono numerose e non è possibile elencarle
tutte. Sul sistema previdenziale, ad esempio, graveranno ulteriori
oneri. Il rapporto tra anziani e lavoratori attivi, che attualmente
è del 20 per cento, dovrebbe salire di quindici punti. Un altro
aspetto che non può essere ignorato è che accorreranno
meno scuole (questa, del resto, è giù una realtà,
visto che proprio all'inizio dell'anno scolastico 1988, fatte le debite
eccezioni, in alcuni casi particolari, come le scuole superiori, le
iscrizioni alle elementari sono diminuite, le aule e gli insegnanti
sono in soprannumero) e, al contrario, serviranno più ospedali
per malati cronici e case di riposo per anziani. Secondo le cifre
dell'Istat, infatti, nel 2018 il numero degli ultra-sessantacinquenni
dovrebbe essere più del doppio di quelli minori di quattordici
anni.
Come si è accennato, la situazione varierà da regione
a regione. Per cui è interessante esaminare le previsioni Istat
più in particolare. Ecco un quadro sintetico delle previsioni
al 2018.
Piemonte: dai
quattro milioni e 600 mila di oggi a tre milioni e mezzo;
Liguria: da un milione e 750 mila a un milione e 250 mila;
Lombardia: da otto milioni e 800 mila a sette milioni e 600 mila;
Trentino-Alto Adige: da 870 mila a 820 mila (in questo caso, la diminuzione
della popolazione riguarda soprattutto la popolazione di lingua italiana,
meno prolifica dei sud-tirolesi);
Veneto: da quattro milioni e 300 mila a tre milioni e 800 mila;
Friuli-Venezia Giulia: da un milione e 200 mila a 900 mila;
Emilia-Romagna: da tre milioni e 900 mila a due milioni e 950 mila;
Toscana: da tre milioni e 500 mila a due milioni e 800 mila;
Umbria: da 800 mila a 660 mila;
Lazio: da cinque milioni e 100 mila a quattro milioni e 800 mila
Abruzzo: da un milione e 300 mila a un milione e 150 mila;
Molise: praticamente costante sui livelli attuali, ma con popolazione
un poco invecchiata;
Campania: da cinque milioni e 600 mila a sei milioni e 700 mila
Puglia: da quattro milioni a quattro milioni e 500 mila;
Basilicata: costante sui livelli attuali;
Calabria: da due milioni e 200 mila a due milioni e 400 mila;
Sicilia: da cinque milioni a cinque milioni e 600 mila;
Sardegna: costante sui livelli attuali.
Dunque, diventiamo
sempre di più un Paese di anziani, e, relativamente, di meridionali.
E' stato già detto che il futuro dovrà prevedere meno
scuole e più ospedali e case di riposo. E' anche probabile
che nella caduta di interesse per le ideologie rivoluzionarie e nel
consolidamento di una mentalità conservatrice questo invecchiamento
giochi la sua parte. Basti pensare che nel 2018 più della metà
della popolazione sarà ultra-quarantacinquenne, mentre nel
1951 coloro i quali avevano superato questa età erano poco
più di un quarto di tutti gli italiani. Nell'arco di una generazione
o poco più, dunque, il nostro Paese ha completamente cambiato
fisionomia. E' ormai piena memoria storica la "grande proletaria"
attiva ancora all'epoca immediatamente successiva alla seconda guerra
mondiale.
E anche all'interno stiamo vivendo grandi cambiamenti. L'area "padana"
vanta oggi un primato mondiale nel decremento demografico con l'Emilia-Romagna,
prima assoluta nella classifica della minore prolificità. Al
contrario, due regioni del Mezzogiorno, la Campania e la Puglia, continuano
a mantenere il primato europeo di prolificità. Due Italie,
ancora e sempre, con comportamenti (e, ovviamente, è da presumere
con redditi) che continueranno ad essere molto diversi. In ultima
analisi, nel complesso delle varie regioni italiane, nel Centro-Nord
ci saranno più di tre persone anziane per ogni ragazzo, mentre
nel Mezzogiorno continentale e insulare il rapporto sarà quasi
di parità. L'identikit può essere questo: il futuro
riguarderà un Paese con un'opulenta, egoista e sviluppata nazione
post-industriale, frammista in modo bizzarro con un'altra, povera
e senza dubbio più vitale.