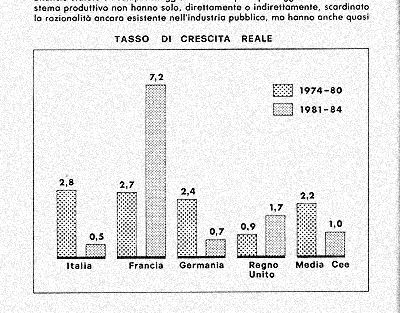Un'analisi
critica delle politiche economiche attuate in Italia dal dopoguerra
ad oggi, una valutazione del quadro economico internazionale e alcune
proposte d'intervento in materia di politica monetaria, fiscale, dei
redditi e del bilancio pubblico sono il cuore di un libro, "L'Italia
al bivio: ristagno o sviluppo", voluto da Vito Laterza e scritto
dall'ex ministro del Bilancio, La Malfa, e da due ex segretari generali
della programmazione economica, Savona e Grilli.
Centrato su un'analisi tecnico-economica dei problemi, che però
non perde mai di vista lo scenario politico e il contesto sociale, il
volume è un atto di fede nella possibilità, per questo
nostro paese, di trovare una via d'uscita dalla crisi sul terreno degli
interventi di politica economica: gli autori denunciano gli eccessi
di assistenzialismo, il ruolo perverso della spesa pubblica; mostrano
diffidenza rispetto alla politica industriale nel suo complesso e a
strumenti come il credito agevolato. Ma appaiono convinti che una manovra
dal lato degli investimenti è comunque necessaria.
Ma quali sono, per gli autori, i più rilevanti problemi di oggi?
La posizione di partenza dell'Italia, rispetto a quella dei maggiori
paesi industrializzati, scrivono, è molto più fortemente
squilibrata e perciò più debole. Ciò si evince
chiaramente dall'esame comparato delle condizioni di produzione, della
dinamica della produttività, dell'efficienza degli investimenti.
Si ritrovano sintomi altrettanto chiari nella dinamica dei prezzi e
negli squilibri tra entrate fiscali e spese pubbliche, tanto in termini
di flussi che in termini di stock di debito, ed infine nelle condizioni
di aggravata e prolungata crisi in cui versa l'amministrazione dello
Stato.
Tutto ciò sovrappone alle ben note caratteristiche della struttura
della produzione industriale, e quindi dell'export, che rendono il nostro
paese, specializzato in produzioni di beni a contenuto tecnologico relativamente
basso, più esposto alla concorrenza derivante dai paesi in via
di industrializzazione.
In termini di crescita della produzione, l'Italia sta perdendo il passo
anche nei confronti dell'Europa comunitaria, la cui crescita è
a sua volta diventata molto più lento di quella del Giappone
e degli Stati Uniti. Questo rallentamento nei ritmi di crescita dell'economia
italiano, che dalla metà degli anni Sessanta era rimasta in linea
con quella dei paesi della Comunità economica europeo, è
fenomeno abbastanza recente, ma riflette dati i cui effetti hanno radici
lontane nel tempo.
La crescita del prodotto reale italiano negli anni Ottanta non è
stata, infatti, solo minore (di circa la metà) di quella dei
paesi della Cee, per non parlare del Giappone e degli Stati Uniti, ma
è stata anche caratterizzata da un forte colo dì produttività.
Il modesto aumento medio annuo del prodotto interno lordo è infatti
avvenuto attraverso la crescita della forza-lavoro impiegato, la cui
produttività non è praticamente più cresciuta.
Il settore pubblico ha inciso non poco su questi risultati negativi.
Per quanto riguarda specificatamente l'industria, gli autori rilevano
che le ristrutturazioni e gli ammodernamenti tecnologici di processo
avvenuti dal 1976 in poi, e con ancora maggior forza durante gli anni
Ottanta, non hanno che minimamente contribuito a cambiare le caratteristiche
di base dell'industria italiana. Pur non cristallizzato in termini di
processi di produzione, il settore industriale è rimasto fortemente
sbilanciato verso produzioni di tipo tradizionale, in termini di caratteristiche
finali del prodotto. Le quote di produzione di settori come il tessile,
l'abbigliamento, i prodotti minerali non metalliferi, la chimica, sul
totale della produzione manifatturiera sono nettamente più elevate
in Italia che nel resto dei paesi industrializzati.
Altro elemento di debolezza per il nostro paese è il basso livello
di efficienza degli investimenti, che sono anche diminuiti come entità.
Perché?
Il calo degli investimenti rispetto al Prodotto interno lordo (Pii)
registrato dal 1973 in poi è legato al peggioramento delle cosiddette
ragioni di scambio: le impennate del prezzo del petrolio e delle altre
materie prime ci hanno imposto di esportare una quota maggiore del prodotto
interno. Ma i consumi interni - notani gli autori - sono rimasti pressoché
stazionari: quindi, l'aggiustamento è avvenuto sul fronte degli
investimenti. Il calo della loro efficienza è poi legato alla
crescita della quota di quelli pubblici e alla progressiva dequalificazione
della spesa pubblica in conto capitale.
La spesa pubblica, inoltre, ha avuto effetti negativi che vanno al di
là dell'immediata percezione dei dati puramente economici.
Sostengono gli autori: la parte meno apparente degli effetti negativi
degli squilibri di finanza pubblica di notevole entità e persistenza
nel tempo è che, se finanziati attraverso l'assorbimento diretto
di risparmio privato, essi tendono gradualmente a ridurre il potenziale
d'offerta del sistema economico, ritardandone in questo modo la crescita.
Questa è la situazione dell'Italia.
La riduzione progressiva della quota di risorse che viene destinata
al mantenimento e all'allargamento dello stock di capitale, ossia l'effetto
d'offerta, è quello più nascosto e più diluito
nel tempo, e per questo è anche quello più pericoloso.
L'evidenza empirica disponibile ne conferma l'esistenza e l'entità
notevole nel caso italiano. Dal 1966 al 1978, il deficit pubblico avrebbe
determinato, secondo le stime disponibili, una riduzione cumulata della
capacità produttiva del sistema industriale di almeno il venti
per cento. Che è come dire: in media, dal 1966 al 1984, il deficit
pubblico ha con tutta probabilità distrutto 1,5 punti percentuali
di crescita della capacità produttiva l'anno.
Un circolo
virtuoso per gli anni Novanta
Per venir fuori dalla crisi e per imboccare la strada che va verso
la piena occupazione, sono necessarie politiche interne rispettose
delle regole del gioco internazionale. Il riferimento non è
solo al vincolo della bilancia dei pagamenti, ma anche al mantenimento
di condizioni "di efficienza e di innovatività dell'economia
sugli standard dei nostri principali concorrenti". Servono quindi
adeguati comportamenti delle autorità di governo, delle imprese,
delle famiglie e delle forze sociali organizzate. Un punto essenziale
è quello del ritorno a processi di accumulazione.
Condizione necessaria per far ciò, sottolineano gli autori,
è che la redditività del capitale ritorni ad essere
positiva. La "falsa compensazione" degli anni Settanta,
quando per sostenere fossi di crescita positivi del salario reale
per unità di prodotto si è lasciato che l'inflazione
rendesse negativi i tassi reali dell'interesse, non è più
proponibile; ciò perché le condizioni esterne che la
resero possibile non esistono più, ma anche perché i
suoi effetti sul processo di accumulazione e di crescita della capacità
produttiva e dell'occupazione sono stati a dir poco devastanti.
Nelle condizioni dell'economia internazionale che si sono descritte,
la prospettiva futura più probabile è che i tassi reali
dell'interesse rimangono positivi per un lungo periodo di tempo. Per
permettere quindi l'accumulazione, il tasso di crescita del costo
reale del lavoro per unità di prodotto deve diventare e restare
negativo. Ciò lascia spazio alla crescita dei salari reali,
ma solo in relazione meno che unitaria alla crescita della produttività
e qualora si aprissero spazi per una minore incidenza degli oneri
sociali.
Se non si farà nulla nei prossimi anni, il Prodotto interno
lordo continuerà a crescere solo del 2,5 per cento, la disoccupazione
resterà sopra il 10 per cento, i prezzi aumenteranno ad un
ritmo doppio rispetto alla media dell'Ocse. Secondo La Malfa, Savona
e Grilli, i problemi vanno così affrontati:
- La politica monetaria. Ad essa va assegnato il compito principale
di mantenere la dinamica dei prezzi entro i limiti prefissati, che
sono dati dai tassi di inflazione nei paesi nostri maggiori concorrenti,
previsti tra il 4 e il 5 per cento l'anno nella seconda metà
degli anni Ottanta.
A questi obiettivi di inflazione e a quelli in precedenza indicati
di crescita reale, ossia di crescita del prodotto in termini nominali,
deve essere adattata la crescita della quantità di moneta.
La Banca d'Italia deve poter disporre di piena autonomia e responsabilità
attuativa. Da questo punto di vista, l'esperienza maturata a partire
dal 1981 con la decisione relativa al cosiddetto "divorzio"
fra Tesoro e Istituto Centrale di Emissione è positiva sul
piano politico, ma deve cambiare contenuti, non essendo il divorzio
solo il modo (peraltro non riuscito) "di creare meno base monetaria".
Insieme con l'abolizione dei vincoli di portafoglio imposti nel passato
(e tornati congiunturalmente nel presente: n. d.ré.), la riduzione
del ruolo giocato dalla Banca d'Italia nel finanziamento del deficit
pubblico impone a questa, come logica conseguenza, la responsabilità
di fissare in modo chiaro e credibile l'obiettivo o gli obiettivi
di crescita della massa monetaria che essa intende perseguire.
L'attuale politica di fissazione dei limiti di credito totale interno
non solo ha perso rilevanza indicativa, ma non risponde più
a nessun chiaro criterio di conduzione monetaria per orientare le
aspettative degli operatori di mercato. Gli operatori-famiglie, imprese
e settore pubblico/Tesoro - necessitano di un quadro monetario fermo
e preciso che la Banca centrale deve potere e volere esplicitare nell'ambito
di una sua sostanziale autonomia operativa.
- La politica dei redditi. Una politica di concertazione centrale
della dinamica delle retribuzioni da lavoro dipendente, cioè
una politica dei redditi inquadrata in un patto sociale per la piena
occupazione, è anch'essa uno strumento necessario. In questo
quadro, la politica dei redditi assume un doppio connotato: da un
lato essa è una politica antinflazionistica, del tipo di quella
discusso e solo in parte sperimentata in questi anni, che accompagna
e rende disinflazionistica e non deflazionistica la politica monetaria;
dall'altro essa deve concorrere alla ripartizione delle risorse fra
consumi ed investimenti per realizzare gli obiettivi di creazione
di nuovi posti di lavoro in precedenza indicati.
- La politica del bilancio pubblico. Questa politica deve riguardare
non solo il disavanzo (che va ricomposto nelle sue componenti reali
e ridotto in quelle finanziarie per lasciare spazio agli investimenti
produttivi ed all'azione monetaria di controllo dei prezzi e delle
aspettative), ma anche l'uso, a fini di sviluppo, della politica fiscale
in senso stretto e della politica della spesa pubblica in generale.
Quanto alla politica fiscale in senso stretto, essa costituisce lo
strumento finale di controllo della dinamica dei redditi di lavoro
dipendente, qualora la concertazione con le parti sociali dovesse
fallire: ma essa costituisce altresì, lo strumento fondamentale
per una politica di controllo del livello e della destinazione dei
redditi diversi da quelli da lavoro dipendente.
Nel campo della spesa pubblica, è evidente la necessità
di una modificazione nella composizione della spesa fra consumi ed
investimenti, questi ultimi essendo limitati nella loro espansione
dall'elevato livello del disavanzo corrente del settore pubblico.
Ma sembra vincere
l'ingiustizia economica
Il futuro economico del nostro paese, affermano gli autori dell'inchiesta,
non è solo incerto, ma è anche soggetto a rischi gravi
e persistenti. le forze politiche e sociali che hanno avuto la responsabilità
della guida dell'Italia lungo l'arco degli anni del dopoguerra portano
la responsabilità di non aver colto il carattere straordinario
delle circostanze di ordine interno e internazionale che accompagnarono
lo sviluppo economico degli anni Cinquanta e Sessanta e di aver fatto
perdere al paese l'occasione fondamentale e con ogni probabilità
irripetibile di portare a soluzione il doppio problema della disoccupazione
e del dualismo territoriale.
La risoluzione di questi problemi avrebbe potuto ben venire dallo
sviluppo di quell'economia mista attorno all'esistenza della quale
c'erano nell'immediato dopoguerra ampi consensi. Fino alla fine degli
anni Cinquanta, si può dire che tale modello abbia funzionato.
All'interno del sistema economico, infatti, si erano venuti sviluppando
un settore privato moderno e concorrenziale ed un settore pubblico
dinamico e produttivo, anche se meno direttamente esposto ai rigori
della concorrenza internazionale.
Mancata l'occasione programmatoria, per difetto di volontà
politica, chiarezza di obiettivi e rigore metodologico, sostituita
di fatto dall'intervento pubblico sregolato al limite della follia
economica, il nostro paese si è trovato del tutto impreparato
ad affrontare i difficilissimi anni Settanta. Impreparato sotto il
profilo economico, ma ancor più sotto quello sociale.
Invece di correggere gli errori del passato, altri e più gravi
ne sono stati commessi, in termini di comportamenti ed ancor più
in termini di omissioni.
Quando i drastici cambiamenti di contesto internazionale avrebbero
richiesto maggiore responsabilità e coerenza di comportamenti,
prevalsero invece l'irresponsabilità politica e sociale. L'accomodamento
di ogni spinta a carico del bilancio statale e i sempre maggiori vincoli
imposti per legge o di fatto sul sistema produttivo non hanno solo,
direttamente o indirettamente, scardinato la razionalità ancora
esistente nell'industria pubblica, ma hanno anche quasi affossato
l'apparato produttivo privato. Quest'ultimo, infine, ha reagito razionalmente
e con vigore, all'interno dei vincoli economici, legislativi e sociali
esistenti, ma lo ha fatto in funzione di sopravvivenza. Il settore
produttivo pubblico è stato invece abbandonato a se stesso,
quando non è stato addirittura aggravato dai pesi morti emergenti
all'interno del sistema produttivo posti via via a suo carico.
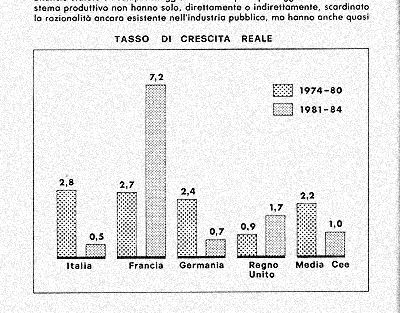
I problemi che oggi si pongono al nostro paese sono più gravi,
non solo perché è continuato e continua il mutamento
del quadro internazionale e perché sono venute meno le condizioni
che ne avevano facilitato la crescita nei due decenni immediatamente
successivi al secondo conflitto mondiale, ma anche perché le
condizioni di relativa saldezza strutturale allora raggiunte, che
potevano aiutare a correggere gli errori di conduzione economica commessi,
sono andate sempre più affievolendosi. Il rigoglio dell'economia
sommersa, lungi dal rappresentare un segno di vitalità, è
un chiaro sintomo di patologia del sistema.
Solo in condizioni di sottoutilizzo strutturale delle risorse esistenti,
di regolamentazione soffocante dell'attività economica e di
impotenza nei meccanismi pubblici di indirizzo e di controllo dell'attività
produttiva è infatti possibile lo sviluppo di un'economia parallela
delle dimensioni di quella esistente in Italia.
Ricordati i fenomeni di disgregazione speciale e la crisi di credibilità
di alcune istituzioni che hanno caratterizzato gli anni Settanta,
gli autori mettono in evidenza il grave processo di emarginazione
che oggi riguarda i cassintegrati, i giovani disoccupati, le aree
di lavoro precario nel Mezzogiorno, i titolari di pensioni minime.
Sono questi, sostengono, i settori della nostra società più
bisognosi di protezione e di aiuto, perché "nessuna democrazia
si regge alla lunga in condizioni di emarginazione dì una parte
consistente delle sue componenti". Dunque, dimensione economica
e dimensione sociale sono due aspetti complementari della stessa realtà.
I tre autori concludono affermando di aver voluto rendere con questo
studio-inchiesta un tributo alla cultura dello sviluppo programmato,
(al quale invece fa riscontro una realtà di ingiustizia economica),
e sottolineando il ruolo della politica economica: "Abbiamo cercato
di chiarire le condizioni per lo sviluppo, frutto di uno sforzo collettivo,
capace di portare la società italiana a realizzare, con le
proprie forze e con i propri comportamenti, quelle trasformazioni
che possano renderla meno esposta ad un possibile peggioramento delle
condizioni internazionali (..). Ci sono alternative a questo disegno?".
La risposta a questa domanda è una scommessa sul nostro futuro.
Debito pubblico
e logica delle stangate
Secondo Recanatesi, la vorticosa crescita del debito pubblico pone
due ordini di problemi. "Il primo è quello monetario,
che consiste nel trovare la quantità di credito necessaria
per finanziare, mese dopo mese e anno dopo anno, il disavanzo dei
conti dello Stato. Tanto maggiore è la quantità di credito
da mobilizzare per le occorrenze dello Stato, tanto più elevati
dovranno essere i tassi d'interesse. Poiché questa quantità
è cresciuta come in nessun altro paese, i tassi d'interesse
in Italia sono più elevati che altrove". Ed è proprio
la crescente tensione dei tassi di interesse che ci porta a considerare
ora il secondo ordine di problemi, "quello più propriamente
economico". Lo Stato è così fortemente indebitato,
per finanziare un disavanzo corrente, ossia una spesa per stipendi,
pensioni, sovvenzioni, contributi, assistenza, integrazioni. Una spesa,
dunque, senza alcun ritorno. Ben altra situazione ci sarebbe, oggi,
se quel l'indebitamento fosse stato contratto per finanziare investimenti:
in questo caso ci sarebbero, a fronte di esso, dotazioni di impianti
e di infrastrutture che consentirebbero al paese un reddito più
elevato, quindi un gettito tributario più consistente, quindi
ancora la possibilità non solo di pagare gli interessi sui
debiti, ma anche di rimborsarli.
Poiché lo Stato si indebita raccogliendo risparmio, è
ragionevole pensare che, se non si fosse indebitato, quel risparmio
avrebbe trovato altri impieghi. E poiché la produttività
degli impieghi che ne ha fatto lo Stato è pressoché
nulla, si può affermare con certezza che la produttività
degli impieghi alternativi che questo risparmio avrebbe altrimenti
trovato sarebbe stata di gran lunga maggiore. Centinaia di migliaio
di miliardi che oggi avrebbero potuto produrre reddito e lavoro sono
stati così dispersi e oggi non ne rimane niente. Se la saggezza
popolare consiglia di regalare a chi ha fame un amo anziché
un pesce, lo Stato italiano si è sempre comportato nel modo
esattamente opposto: ha distribuito assistenza invece di predisporre
quanto necessario perché ciascuno, con il proprio lavoro, in
ogni regione d'Italia, potesse produrre il reddito necessario per
vivere dignitosamente. Un calcolo necessariamente opinabile, ma non
per questo meno significativo, ha indicato in 900 mila posti di lavoro
il costo in termini di occupazione imposto dagli squilibri della finanza
pubblica.
Ora, anche questo spreco di risorse si autoalimento. Il continuo rinnovo
del debito impone tassi d'interesse che superano, e di parecchio,
il ritmo della crescita del reddito nazionale. In parole più
semplici, questo significa che della ricchezza prodotta dall'intero
paese una quota crescente deve essere destinato alla remunerazione
degli investimenti finanziari, a spese, ovviamente, di quanti svolgono
un'attività produttiva. In definitiva, se il debito si autoalimenta,
parallelamente si autoalimenta l'impoverimento che esso determina
per il sistema economico. La funzione redistributiva del settore pubblico
si è spinta, quindi, fino a prelevare quanto serve al sistema
per produrre la ricchezza che lo Stato stesso intende redistribuire.
Questo fenomeno si chiama "deindustriaIizzazione": un termine
che mette soggezione pronunciare in un paese che ancora comprende
vaste aree economicamente arretrate e che deve sopportare un'elevata
disoccupazione concentrata nelle generazioni che si affacciano alla
vita produttiva. D'altra parte, come si potrebbe spiegare altrimenti
che l'industria nazionale si è ristrutturata, è tornata
competitiva, ha recuperato redditività, ma si guarda bene dall'ampliare
il proprio potenziale produttivo, ad aprire nuove fabbriche, ad arruolare
manodopera?
Il problema del debito pubblico, dunque, non è soltanto finanziario.
Tutt'altro! E', anzi, l'origine di molte patologie che ci portiamo
dietro da molti anni: dall'inflazione alle periodiche svalutazioni
della lira; dallo squilibrio commerciale alla disoccupazione. D'altra
parte, non possono esistere a questo punto soluzioni morbide e indolori,
ma solo cure radicali e profonde. Non sacrifici, ossia tributi da
accettare solo per poter tirare avanti come prima, ma un'operazione
di riconversione della spesa per "distribuire ami anziché
pesci". Pagare un ticket dopo che ci era stata promessa un'assistenza
sanitaria gratuita da fastidio, ma pagarlo nel quadro di un progetto
politico coerente nel quale abbia, come in effetti può avere,
la contropartita di una moneta più stabile, di servizi più
efficienti, di nuove fabbriche e di maggiori opportunità di
lavoro, sarebbe forse un fastidio?
Uscire dalla logica miope e rinunciataria dei sacrifici, dei tagli,
delle stangate per alzare il tiro su un grande progetto politico ed
economico di valorizzazione di tutte le energie produttive che esistono
nel nostro paese è anche un'impegnativa operazione di risanamento
finanziario e di riduzione dell'indebitamento, ma è soprattutto
una grande riconversione del nostro sistema economico, nella quale
la maggioranza dell'elettorato, cioè dei cittadini che pagano
le tasse, potrebbe riconoscersi per premiare, non per punire, le forze
politiche che trovassero il coraggio e l'impegno necessari per affrontarla.
Qual'è
il patrimonio pubblico
Può essere utile, intanto, cominciare a fare i conti in tasca
a questo Stato sprecone. E vedere come sono utilizzate le risorse
di cui dispone. Per molti, infatti, siamo già nell'epoca post-industriale,
ma da noi esistono ancora i grandi proprietari terrieri e immobiliari.
O meglio: ce n'è uno che fa impallidire tutti, ed è
proprio lo Stato. Suoi sono lidi, spiagge, fiumi, laghi. Sue le foreste
e le miniere. Suoi i palazzi adibiti a sedi di ministeri e di altre
strutture statali, le case popolari, gli aeroporti, le raccolte dei
musei. Un proprietario ricchissimo e tollerante, persino "sbadato".
Se gli occupano un terreno, passano decenni prima che riesca a rientrarne
in possesso. Se ci riesce.
Finita la guerra, l'idroscalo di Ostia non venne più utilizzato
dall'Aeronautica. Fu sdemanializzato nel '58, per passare a patrimonio
statale. Ma quando i funzionari vi si recarono per prenderlo in consegna,
vi trovarono già baracche abusive, orticelli, villini. Solo
dopo sentenze su sentenze si riuscì a "ripulirlo"
e a cacciare parte degli abusivi. A Rodi Garganico, stessa storia.
Con una vittoria a metà: si è ottenuto lo sgombero,
ma non la demolizione delle costruzioni abusive. Sulla proprietà
statale torna a vigere il diritto dell'uomo primitivo di Rousseau,
che acquisì il proprio possesso cingendo per primo un campo.
C'è una sorta di lassismo morale, che considera il bene dello
Stato come il "bene di nessuno". E, per di più, neanche
lo Stato conosce la reale entità delle sue ricchezze. Ne ignora
la localizzazione, lo stato di conservazione, gli usi, il valore.
Si è dovuta nominare una Commissione, che ha il compito di
censire tutto.
Il problema è annoso. Già nel maggio '47, con decreto
del Capo dello Stato provvisorio, De Nicola, venne istituita una Commissione
per l'accertamento della proprietà immobiliare statale. Ma
non se ne fece nulla. Si tornò a parlare nel '63: se ne occupò
Massimo Severo Giannini nel suo famoso rapporto sull'amministrazione.
Risultati: pressoché zero. Un'ultima iniziativa è partita
dai Beni Culturali.
Ma come mai lo Stato non conosce le proprie ricchezze? Il problema
è lo "spezzettamento". Cioè: i beni non fanno
capo a un'unica struttura, ma sono inventariati e gestiti da enti
diversi, in particolare dai singoli ministeri ai quali l'amministrazione
finanziaria ha concesso "in uso governativo" tanta parte
del patrimonio, e che adesso sono di fatto i reali detentori e amministratori
della proprietà statale.
E pertanto: il demanio marittimo spetta al ministero della Marina
Mercantile; quello militare alla Difesa; quello artistico-culturale
ai Beni Culturali: ferrovie e aeroporti al ministero dei Trasporti;
il patrimonio minerario spetta al ministero dell'Industria; il demanio
stradale e idrico a quello dei lavori Pubblici; al segretario generale
della Presidenza della Repubblica è riservata l'amministrazione
dei beni in dotazione al Capo dello Stato. A questo "spezzettamento
orizzontale" va aggiunto, da qualche anno, quelle "verticale",
costituito dalle Regioni, alle quali, con il trasferimento di funzioni
centrali, è stata anche assegnata la gestione dei beni corrispettivi
(miniere, cave e torbiere, acque interne, fino agli ospedali). Ci
sono poi le Province e i Comuni. Una frantumazione farraginosa e anacronistica,
fonte di caos amministrativo, di sperperi, e che, come vedremo, da
più parti si propone di superare.
Per fare i conti in tasca a questo Stato, bisogna rifarsi a pazienti
indagini di ancor più pazienti ricercatori, in mancanza di
dati ufficiali. Una ricerca risalente al 1971, ("i dati possono
aver subito una variazione del 10 per cento", dicono gli esperti)
indica in 1.215 mila miliardi e 5 milioni il patrimonio in valore
dello Stato, di cui oltre la metà in uso governativo.
Recentemente, poi, l'Arel (Agenzia di ricerche legislative), sulla
base del censimento dell'81, ha ricavato dati inediti. Immobili: su
86.570.148 stanze censite, i soggetti pubblici (ministeri, enti locali,
lacp, ecc.) ne posseggono 36.148.000. Terreni: escluso il demanio,
lo Stato possiede 381.726.398 metri quadri. Di questi, 246.836.010
metri quadri sono "patrimonio disponibile", (può
essere venduto); il resto è "patrimonio indisponibile".
Patrimonio immenso, ma rendite minime. Sempre secondo l'Arel, tutto
questo dovrebbe far fruttare allo Stato, nel 1986, una cifra pari
a 271,9 miliardi di lire: in pratica, lo 0,1% delle entrate complessive.
I dati ricavati dal bilancio di previsione rivelano che dai diritti
per concessioni si dovrebbero ricavare 105,8 miliardi; da affitti,
canoni e concessioni immobiliari, 22,5 miliardi; dalle acque pubbliche,
89,5 miliardi; dal demanio marittimo, 36,7 miliardi. Dati che non
si discostano poi di tanto da quelli ufficiali forniti dalla Direzione
generale del demanio, che nell'84 ha incassato 299 miliardi e 400
mila lire circa, 15 miliardi in più rispetto all'anno precedente.
Fatta la debita "tara" da inflazione, si può dire
che i beni statali producono le stesse entrate di venti anni fa: nel
'64, fra demanio e patrimonio, furono di poco superiori ai 20 miliardi
di lire.
Non è che lo Stato abbia contratto voto di povertà.
Il fatto è che sono in buona parte le stesse norme vigenti
a determinare questa situazione. Ci sono tre parole-chiave: "uso
gratuito", "concessione" e "canone". Indicano
i modi diversi di "appalto" dei beni pubblici a soggetti
diversi.
In uso gratuito sono tutti i palazzi e gli immobili sedi di ministeri.
Fino al 1923, le varie amministrazioni pagavano ancora un fitto al
Demanio; ma da quell'anno una legge, tuttora valida, ha stabilito
che "i beni immobiliari assegnati a un servizio governativo si
intendono concessi in uso gratuito ai ministeri, e sono da questi
amministrati". Si dirà: tanto, sono sempre soldi dello
Stato risparmiati a favore delle sedi delle varie amministrazioni.
Ma i conti non tornano più quando si scopre che diversi ministeri
possiedono a loro volta beni patrimoniali che "concedono",
usano o affittano a prezzi simbolici e, nello stesso tempo, per trovare
nuove sistemazioni per i propri uffici sono costretti a ricorrere
al mercato immobiliare privato. il ministero delle Finanze, ad esempio,
per i locali del primo ufficio distrettuale delle imposte dirette
di Roma paga a privati intorno ai due miliardi di affitto all'anno.
Ci sono poi beni dati in concessione dietro pagamento di canoni, questi
ultimi stabiliti dalla Direzione generale del demanio, competente
per le entrate.
Entrate o elemosina? Basterà citare alcuni canoni per rendere
l'idea. I dati sono tratti dall'ultima circolare che ne stabilisce
gli adeguamenti (è dell'82; i precedenti adeguamenti risalivano
al '61). Per i cantieri navali, si passo da 30 lire al metro quadro
del '61 a 240 lire. Per le concessioni minerarie, 3.200 lire per ogni
ettaro di terraferma. Se poi si vogliono avere permessi di ricerca
sulla superficie del mare, basterà la miseria di 10 lire. Ancora:
l'uso di acqua pubblica a scopo di irrigazione costa 64 mila lire
l'anno (la metà, se si restituiscono i residui). Gli importi,
precisa il Demanio, "non possono essere inferiori a 5 mila lire
annue per utilizzazioni a scopo irriguo e a 30 mila lire per altre
utilizzazioni". Il Demanio come opera pia? Eppure, acque, cave,
spiagge diventano oro in mano ai privati.
Dice il Demanio: certo, i canoni non sono alti, ma il demanio, per
sua natura, serve all'utilità pubblica. Intanto, ci sono casi
microscopici di morosità o di pagamenti "sfuggiti"
alla conta. E ribattono all'Arel: il criterio dei canoni è
ancora quello che si applicava nell'Italia dei mulini. Facciamo qualche
esempio. Il demanio marittimo: coste e spiagge. Una volta questo non
era altro che un "luogo di confine", sul quale erigere qualche
fortificazione. Ma oggi? Non è esagerato dire che ai nostri
giorni le coste sono uno dei beni più appetiti, sui quali si
scarica un'enorme pressione: le industrie chimiche e petrolchimiche,
quelle dell'acciaio e della ghisa, le centrali nucleari, gli stabilimenti
balneari, il turismo di massa. L'Ance calcola che oltre il 50% dell'abusivismo
edilizio è a ridosso delle coste. Ma allora, se la situazione
è questa, si può continuare con una gestione in mano
all'attuale Demanio, rimasta di fatto come un secolo fa, con canoni
da 600 lire al metro quadro? Stando al bilancio di previsione per
l'86, lo Stato dovrebbe incassare dai canoni sul demanio marittimo
appena 36 miliardi: si può immaginare di risolvere così
il problema, ad esempio, del degrado delle coste, e del disinquinamento
delle acque? Solo per disinquinare il Po e l'Arno ci vogliono circa
2.000 miliardi.
Le proposte. Forse non si tratta tanto di aumentare i canoni, quanto
di affrontare il tutto in termini manageriali, valutando costi e ricavi.
Se allo Stato un bene non serve più, lo immetta sul mercato
e lo vendo. Nelle casse pubbliche affluirebbe un bel gruzzolo: Andreatta
parla di 30 mila miliardi di lire. L'amministrazione, oltre tutto,
si alleggerirebbe di enormi costi di gestione passivi. Poi, c'è
un'altra proposta: quella di istituire un'Azienda per il patrimonio
dello Stato, come in Francia o negli Stati Uniti. In America, il principio
è che la gestione dei beni pubblici è un "big business":
lo Stato li gestisce imprenditorialmente. Ma lì lo Stato, per
lo meno, sa quel che possiede, e dove lo possiede. Da noi, in clima
di sprechi e di assistenzialismo selvaggio, gli inventari sono ancora
tutti da fare.
Ricchi poveri nullatenenti
Demanio, patrimonio,
beni dello Stato. Sono termini che stanno a indicare "le ricchezze
pubbliche", ma specificano diverse specie giuridiche di possedimento.
Demanio.
L'art. 822 del Codice civile elenca i beni che fanno parte del demonio:
il lido del mare, le spiagge, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti,
i laghi, le opere destinate alla difesa nazionale. E' questo il demanio
considerato "necessario", al quale va affiancato quello
"accidentale": strade, autostrade, ferrovie, aerodromi,
acquedotti, raccolte di musei, pinacoteche, biblioteche, immobili
di interesse storico-artistico. Caratteristica dei beni demaniali
è la loro "inalienabilità". Per essere venduti
o passare di mano devono prima essere "sdemanializzati".
Lo Stato può darli in "concessione".
Patrimonio
indisponibile. Le foreste, miniere, cave e torbiere, caserme,
navi da guerra, tutti gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici;
i beni in dotazione alla Presidenza della Repubblica. Caratteristica
di questi beni è che non possono essere-sottratti alla loro
destinazione, se non con apposite leggi.
Beni in uso
governativo. Sono più della metà del patrimonio
statale. Su un totale generale di 1.215 miliardi 5 milioni 165 mila
920 lire in valore dei beni statali, i beni "in uso governativo"
ammontano a 679 miliardi 656 milioni 179 mila 965 lire: in percentuale,
il 55,94%.
Ricchezze dei
ministeri. Nella distribuzione percentuale per ministeri, la Difesa
fa la parte del leone, con una dotazione di oltre il 57,28 per cento
dei beni statali in uso governativo. Seguono le Finanze (9,48%), gli
Interni (8,74%), Grazia e giustizia (7,01%), Pubblica Istruzione (4,68%,
ma precedente all'istituzione dei Beni Culturali, avvenuta nel '75),
Lavori Pubblici (3,22%), Agricoltura (1,81%), Tesoro (0,86%), Esteri
(0,77%). I ministeri più poveri sono quelli dei Trasporti e
della Marina Mercantile, rispettivamente con lo 0,26% e con lo 0,20%.
Distribuzione
regionale. La maggior parte dei beni sono concentrati nel Lazio:
27,87%. E' conseguenza ovvia della concentrazione a Roma della maggior
parte dei ministeri. Seguono Lombardia (8,77%), Campania (7,32%) ed
Emilia-Romagna (6,59%). Le regioni con meno beni in dotazione risultano
la Valle d'Aosta e il Molise, con 0,28% e 0, 18%.
|