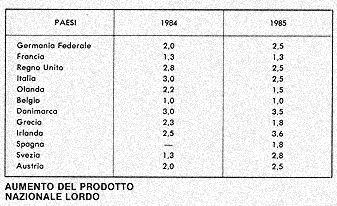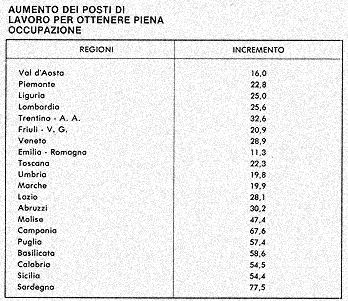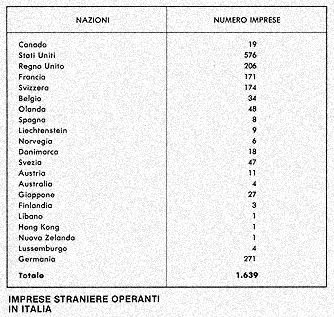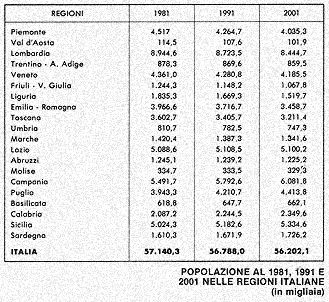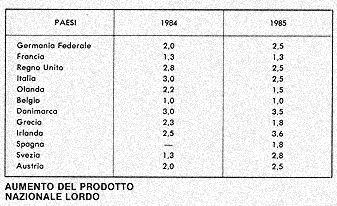L'aumento
del 5,3% per il 1984 del costo del lavoro per unità di prodotto
(Clup), previsto nella Relazione previsionale e programmatica, aveva
suscitato perplessità e, da alcune parti, tentazioni per un suo
uso strumentale. Dopo aumenti medi tra il 15 e il 20% registrati negli
ultimi dieci anni, questo dato era almeno in parte sorprendente. E qualcuno
era stato già indotto a pensare che sul versante costo del lavoro
si forse fatto molto e non accorressero ulteriori interventi di contenimento.
Certo, ogni previsione è sempre carica di ipotesi soggettive
e di incertezze. Sul Clup, inoltre, influiscono diverse variabili, ciascuna
delle quali può determinare rilevanti effetti positivi o negativi.
E d'altra parte, altri centri di previsione (Wharton, Confindustria,
Prometeia), forse più correttamente, avevano indicato valori
compresi tra l'8 e il 10%. Ma per valutare più oggettivamente
l'andamento del Clup, è necessaria una duplice analisi:
a) da un lato, bisogna confrontare il dato "puntuale" dell'anno,
con i risultati che in questo stesso anno sono stati ottenuti dagli
altri Paesi industriali;
b) dall'altro lato, è necessario inquadrare questo valore annuale
in un profilo di medio e di lungo termine, per poter valutare i movimenti
strutturali che si possono individuare solo nell'arco dei 5-10 anni.
Ebbene dalle previsioni Wharton, omogenee per tutti i Paesi industriali,
risulta che nell'84 il Clup in Italia doveva aumentare di quasi il 7%,
contro una crescita pari all'1% in Giappone, al 2,2% negli Usa, all'1,7%
nella Germania Federale, al 4,5% nel Regno Unito, e al 6,1% in Francia.
Quindi nonostante tutto, questo risultato italiano apparentemente sorprendente
rimaneva comunque il più alto incremento verificatosi tra i Paesi
industriali.
Ma, oltre a queste divergenze di vedute e di valutazioni, spesso si
determina anche qualche confusione tra variabili che esprimono fenomeni
e significati diversi tra loro. Tre sono gli indicatori rilevanti da
valutare nel medio periodo:
1) dal punto di vista del lavoratore: l'andamento del potere di acquisto
della sua retribuzione, espresso dall'aumento nominale depurato dall'incremento
dei prezzi al consumo;
2) dal punto di vista delle imprese: l'andamento del costo "reale"
del lavoro, espresso dall'aumento del costo nominale del lavoro depurato
dall'aumento dei prezzi all'ingrosso come approssimazione dei prezzi
delle imprese produttive;
3) dal punto di vista dei lavoratori, delle imprese e dell'intero sistema
economico (proprio perchè indicatore importante della competitività,
della produttività, dell'occupazione, ecc.): il costo del lavoro
per unità di prodotto, espresso dall'andamento del costo del
lavoro e dalla produttività.
Il potere d'acquisto
Nell'arco del decennio '75-85, l'Italia ha sperimentato il più
alto incremento del potere d'acquisto della retribuzione per lavoratore,
pari a circa il 21%. Francia e Regno Unito si collocano anch'essi
su questo livello, mentre lievemente inferiore appare l'aumento verificatosi
in Giappone. Segue a distanza, con un aumento del 16%, la Germania.
Gli Usa invece sono l'unico Paese che nel corso di questi dieci anni
ha visto ridursi il potere d'acquisto che, anche nel 1985, si manterrà
inferiore ai livelli del 1975.
Costo reale
per le imprese
L'aumento del costo del lavoro "reale" è stato pari,
sempre nel decennio, al 52% in Giappone, al 34% in Francia, al 27%
in Italia, al 15% nel Regno Unito e solo al 9% negli Stati Uniti.
Andamento dello
produttività e Clup
La produttività per addetto vede in testa il Giappone, con
un aumento del 38%, e in coda gli USA con aumento appena superiore
al 10%. In posizione intermedia risultano i Paesi europei che vedono,
però, da un lato, Francia, Germania e Regno Unito collocarsi
tra il + 24% e il + 26%, e dall'altro lato l'Italia con il + 19%.
Infine, questo è l'aumento del Clup in questi anni: Italia
+ 311%, Francia + 154%, Regno Unito + 138%, Stati Uniti + 82%, Giappone
+ 43%, Germania + 36%.
Come si vede,
quindi, la distanza accumulata in questo decennio in termini di Clup
da parte dell'economia italiana è così ampia, da ridimensionare
notevolmente gli eventuali entusiasmi sul "buon risultato del
1984". Guardando a questi andamenti decennali, si può
inoltre rilevare che:
a) tutti i Paesi europei hanno di fatto seguito una politica di aumento
progressivo del potere d'acquisto del singolo lavoratore. Tale aumento
è stato però inferiore all'aumento della produttività
in Francia, Germania e Regno Unito. Per contro, invece, esso è
stato superiore all'aumento della produttività in Italia. Nel
nostro Paese, dunque, il lavoratore occupato ha ricevuto tutta la
produttività e qualche cosa in più;
b) contrariamente a qualche diffuso luogo comune, negli Usa l'aumento
della produttività per lavoratore risulta essere il più
basso tra i Paesi industriali e il vero punto di forza dell'economia
americana sembra essere la flessibilità delle retribuzioni,
insieme con le diverse condizioni operanti nel mercato del lavoro.
Si possono quindi vedere tre diversi modelli di comportamento legati
alle tre grandi aree economiche del mondo:
1) il Giappone, che trova la sua forza trainante nell'aumento della
produttività e usa questo aumento, per metà, per aumentare
il potere d'acquisto dei lavoratori e, per l'altra metà, per
destinarlo a profitti e/o contenimenti di prezzi, volti a rafforzare
la competitività internazionale;
2) gli Stati Uniti, che hanno una bassa dinamica di produttività,
ma la destinano totalmente a profitti e/o a contenimento dei prezzi;
3) l'Europa, che ha una dinamica di produttività intermedia
tra le altre due aree, ma la destina quasi totalmente all'aumento
del potere d'acquisto delle retribuzioni. Al suo interno si colloca
l'"anomalia" italiana, che destina a questo più della
stessa produttività.
Non è quindi sorprendente "scoprire" che nel decennio
'75-85 nel totale dei Paesi industriali l'occupazione è aumentata
a ritmi sostenuti. Se si includono le previsioni, a questo punto abbastanza
attendibili, per il prossimo anno, si rileva che si è avuto
un aumento di oltre 28 milioni di posti di lavoro, molto di più
dei 19 milioni di posti creati nel precedente decennio '65-75. Il
fatto è che questo aumento di occupazione risulta tutto concentrato
negli Usa e in Giappone (+ 22,3 e + 6,6 milioni, rispettivamente),
mentre l'Europa ha avuto addirittura una riduzione complessiva dei
suoi livelli occupazionali.
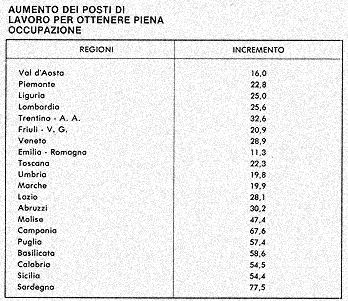
Quindi, nonostante le gravi difficoltà economiche e finanziarie
di questo cosiddetto "decennio di crisi", non è stata
l'occupazione complessiva dei Paesi industriali a deflettere, ma si
è verificata una imponente redistribuzione internazionale del
lavoro, quasi una silenziosa e invisibile migrazione biblica: gli
Usa hanno aumentato la loro quota di posti di lavoro dal 37,8% al
42,4%, il Giappone ha mantenuto il suo 22,5%, mentre l'Europa è
scesa dal 40% al 35% del totale dei posti di lavoro nei sei maggiori
Paesi industriali. Da questo punto di vista, "miracolosa"
appare la situazione occupazionale e anche l'andamento degli investimenti
in Italia. Come conseguenza dei dati precedenti, infatti, il nostro
Paese avrebbe dovuto avere una pesante riduzione di occupazione. Al
contrario, risulta essere l'unico Paese europeo ad aver aumentato
l'occupazione in questi dieci anni di quasi il 6%. E ciò, nonostante
un aumento del potere d'acquisto dei lavoratori superiore all'aumento
della produttività e nonostante l'imponente aumento del costo
del lavoro per unità di prodotto.
Ma questo spiega, in buona parte, quella sanatoria "ex post"
che la nostra economia ha trovato, svalutando periodicamente il cambio
della lira. Questo risultato appare però "poco miracoloso"
e per molti versi irripetibile e preoccupante se si considera che
l'aumento di occupazione verificatosi in Italia è di fatto
dovuto quasi interamente al settore del pubblico impiego che, nel
periodo 1975-83, ha assorbito oltre 600 mila persone in più.
Ecco allora che il "miracolo" assume piuttosto i connotati
di un "trucco", di una disoccupazione nascosta a fronte
della quale c'è l'imponente aumento del debito pubblico e del
debito estero, vale a dire la montagna di cambiali che abbiamo fatto
firmare ai nostri figli, a loro insaputa.
In dodici anni
tante Caporetto
Come è nato, come è andato allargandosi così
vistosamente il buco dei conti dello Stato, fino a giungere ai limiti
del dissesto? E' salita troppo la spesa o sono state troppo modeste
le entrate? E perchè lo Stato non ha bloccato la forbice che
andava determinandosi fra le due voci, prima che il buco diventasse
voragine?
Nel rispondere a queste domande, quasi tutti gli economisti sembrano
d'accordo.
Primo punto: la formazione dei disavanzi crescenti nei conti dello
Stato è stata determinata, negli ultimi dodici anni, da una
crescita relativamente rapida della spesa pubblica complessiva alla
quale, almeno in un primo tempo, non ha tenuto dietro un adeguato
aumento delle entrate. Quando il recupero inizia e la riforma fiscale
va a regime, è ormai troppo tardi: il buco si è già
formato e la spesa si è messa a correre ancora più velocemente,
sull'onda di un assistenzialismo crescente.
Secondo punto: questo gap, questa divaricazione fra entrate e uscite,
sono stati favoriti da un accentramento a livello statale della quasi
totalità degli introiti fiscali, e al contrario, da un decentramento
crescente delle decisioni di spesa ad altri Enti pubblici, come i
Comuni, le Province, le Regioni. Se si esclude la spesa per interessi
e trasferimenti agli altri Enti pubblici - sostiene Alberto Majocchi,
che ha curato una poderosa ricerca dell'Università Bocconi
sul deficit pubblico - risulta che lo Stato controlla direttamente
solo una minima parte delle risorse che è in grado di erogare:
attualmente, il 33% del totale delle spese, contro il 65% del 1965.
E quando chi incassa non ha il controllo sulla spesa e chi spende
non ha anche la responsabilità di trovare il modo di procurarsi
i quattrini necessari, i conti fanno presto ad andare in rosso. Insomma,
tutti sono d'accordo che giunti a questo punto è proprio sulla
spesa, più che sull'entrata, che bisogna agire per riequilibrare
i conti pubblici: tagliando, riqualificando e ristabilendo un criterio
di responsabilità anche a livello periferico.
Ma come, e in che direzione è necessario muoversi? Perchè
la guerra intrapresa (o almeno dichiarata) negli ultimi anni da tutti
i governi contro il deficit pubblico ha avuto così scarsi risultati?
Gli insuccessi, o comunque gli inadeguati successi, sono attribuibili
solo a incapacità o a scarso voglia di procedere sulla strada
delle decisioni impopolari, o la riduzione della spesa pubblica è
davvero una delle fatiche di Ercole?
Per capirlo, occorre prima rendersi conto, sia pure con largo approssimazione,
di quali voci è composta la spesa pubblica nel suo complesso,
come questa spesa è strutturata e, elemento essenziale, quale
è stata la dinamica dei singoli settori in questi anni sia
rispetto al reddito nazionale sia rispetto all'andamento delle entrate.
E sotto questo profilo un'analisi più dettagliata riserverà
delle autentiche sorprese e farà cadere molti luoghi comuni.
Nell'analizzare la composizione della spesa pubblica corrente ci si
imbatte immediatamente in una realtà che rende quanto mai difficile
una taglio drastico e rapido delle uscite dello Stato. Dice l'economista
Maria Teresa Salvemini: "Da qualunque parte escano i soldi, la
spesa pubblica nel suo complesso è prima di tutto una somma
di stipendi e di redditi diversi che direttamente o indirettamente
arrivano alle famiglie. E per ridurre la spesa bisogna quindi necessariamente
tagliare i redditi a qualcuno". E spiega il professor Mario Baldassarri:
"è essenziale rendersi conto che poco meno del 70% della
spesa corrente è dovuto in pratica a salari, stipendi e pensioni.
Il resto della spesa è dovuto ad interessi sul debito pubblico,
difficilmente contenibili a breve termine, e per solo il 12% ed acquisto
di beni e servizi, che hanno comunque positivi effetti sul sistema
economico".
Questa situazione della struttura delle uscite correnti, che generalmente
non viene sottolineata con la dovuta evidenza, comporta dunque una
prima constatazione: se il 70% delle uscite è composto da stipendi
e pensioni, ridurre consistentemente le spese comporterebbe consistenti
tagli su queste voci. Determinando, di conseguenza, forti tensioni
sociali e forti rischi di una riduzione della domanda interna, con
relativa spinta recessiva. La seconda constatazione è lo strettissimo
nesso che corre fra livello della spesa pubblica e politica dei redditi.
Con questa composizione della spesa pubblica qualunque aumento nella
dinamica dei salari, degli stipendi e delle pensioni comporta un immediato
aumento della spesa corrente. E viceversa. Sostiene Majocchi: "L'evoluzione
dei redditi nominali nel settore privato incide in modo significativo
anche sull'andamento della spesa pubblica: retribuzioni dei dipendenti
pubblici e pensioni. Il controllo della spesa presuppone quindi a
monte una politica dei redditi per evitare effetti che hanno origine
nel settore privato e che non possono venire controllati direttamente
attraverso decisioni limitate al campo della finanza pubblica".
E questo spiega perchè un contenimento della scala mobile e
comunque della dinamica delle retribuzioni è indispensabile
anche per il contenimento del disavanzo pubblico; ed ecco perchè
appare quantomeno incoerente chi chiede una riduzione della spesa,
opponendosi nello stesso tempo a una riduzione della dinamica dei
salari che, come confermano gli ultimi dati, continua a marciare a
livelli più elevati dell'inflazione.
L'eccesso di
spesa non viene dai ministeri
Stabilito che la maggior parte della spesa pubblica è fatta
di retribuzioni e di pensioni, vediamo di capire quali sono effettivamente
i singoli settori che negli anni scorsi hanno contribuito di più
alla formazione dei disavanzi. Per semplificare il discorso, e anche
per chiarire meglio quanto è successo all'interno della finanza
pubblica dagli anni felici del surplus del settore pubblico a quelli
dei disavanzi a dodici cifre, non seguiremo la classificazione utilizzata
generalmente dagli schemi di contabilità Economica generale,
ma piuttosto quelli elaborati dal professor Giuseppe Alvaro, ordinario
di Statistica economica all'Università di Roma. Questa classificazione
comprende praticamente quattro voci che assorbono più o meno
l'intero bilancio dello Stato:
1) le spese sostenute per la prestazione dei servizi pubblici di carattere
generale, come la difesa, l'istruzione e la giustizia, che sono poi
le spese dei diversi ministeri;
2) quelle sostenute dallo Stato a favore delle famiglie per le prestazioni
sociali in senso stretto, come la sanità, la previdenza e l'assistenza;
3) quelle sostenute per attenuare le difficoltà che si determinano
nel settore produttivo, come i contributi correnti alla produzione,
i finanziamenti delle Partecipazioni Statali, le spese per la Cassa
integrazione e quelle per sostenere gli investimenti;
4) gli interessi sul debito pubblico, cioè quelli che lo Stato
paga annualmente ai risparmiatori che acquistano Bot e Cct per finanziare
i suoi deficit vecchi e nuovi.
Ebbene, nell'analizzare singolarmente queste voci della spesa pubblica,
la sorpresa viene proprio dal settore ministeriale. Contrariamente
ad una valutazione molto diffusa che attribuisce proprio alla struttura
burocratica statale una grave responsabilità nell'andamento
dissestato dei nostri conti pubblici, non è affatto dalle spese
per la prestazione di servizi pubblici generali che il disavanzo pubblico
è stato gonfiato. Difesa, istruzione, giustizia e le altre
attività ministeriali sicuramente potevano e potrebbero essere
assai più efficienti, ma certo non sono cresciute più
del reddito nazionale e delle entrate. In tutto il periodo 1964-79,
sostiene Alvaro, le spese per i servizi pubblici generali, più
quelle per gli investimenti, hanno assorbito costantemente il 14%
del prodotto interno lordo. Solo a partire dal '79 si registra un
aumento di un punto percentuale all'anno. Ma rispetto alle entrate
correnti, il complesso delle due voci presenta una andamento tendente
alla diminuzione anche negli ultimissimi anni, confermando che non
sono queste spese la causa della formazione dei crescenti disavanzi.
"La quota della nostra pubblica amministrazione sul Pil (11,5%
- dice il professor Antonino Giannone - risulta più bassa della
Francia (12,2), dell'Austria (12,9) della Germania (13,2), dell'Australia
(15,3) e del Regno Unito (17,8), e poichè il prodotto della
pubblica amministrazione è costituito essenzialmente dalle
retribuzioni dei dipendenti, questi dati smentirebbero le frequenti
affermazioni circa un "altissimo costo" della burocrazia
nel nostro Paese". D'altro canto, la spesa per il personale pubblico
in Italia, afferma un'altra studiosa, la professoressa Angela Fraschini,
pur essendo aumentata notevolmente in valore assoluto (da poco più
di 2.000 miliardi nel '65 a circa 30.000 nell'82), è cresciuta
in misura esigua come quota sul Pil: dal 5,6% al 6,4%, nello stesso
periodo.
Tirando le somme, la voce dei servizi pubblici va quindi depennata
dalla lista nera, nella quale restano le altre voci, e a pieno titolo,
con il settore delle prestazioni sociali come maggiore indiziato.
Deregulation
prima di tutto
La "deregolamentazione", cioè l'eliminazione di norme
e disposizioni che distorcono il regolare sviluppo delle attività
economiche e finanziarie, a questo punto, e nelle condizioni sopra
osservate, è la carta più importante che possiamo (e
dobbiamo) giocare. Il perché è evidente: l'approccio
pragmatico, tipico della deregulation correttamente intesa, può
far superare i bracci di ferro tra le forze politiche, e portare a
cambiamenti importanti e significativi anche nel campo della spesa
pubblica.
A parole, il discorso è facile. Nei fatti si presenta complesso.
Spinte e controspinte si susseguono, come dimostra la lettura della
voluminosa documentazione trasmessa al Parlamento, e come confermano
iniziative e proposte di volta in volta elaborate per rispondere a
sollecitazioni di singoli gruppi d'interesse. Bisogna però
cercare di farlo, e al più presto, questo discorso della deregulation,
sia che riguardi aspetti minuti (o "leggeri", come li ha
chiamati la Confindustria), sia che abbracci quelli più generali
(o "pesanti", per riprendere la precedente qualificazione).
Un discorso che va condotto in modo non ideologico. E' stato recentemente
osservato: "Non commettiamo l'errore di fare della deregulation
il cavallo di Troia per espugnare ciò che si dimostra da anni
inespugnabile" (cioè la riforma istituzionale). Una prima
regoletta da applicare è dunque quella di procedere pragmaticamente,
affrontando e risolvendo i singoli "casi", trovando specifiche
soluzioni. Una seconda è quella di valutare la deregulation
non come semplice rimedio a problemi burocratici e a disfunzioni interne
degli uffici, ma come sollievo per l'impresa e per il cittadino. In
altre parole: va bene alleggerire le inutili attività burocratiche,
purchè ciò si rifletto positivamente sulla qualità
dell'azione amministrativa a vantaggio del cittadino e dell'impresa.
Si è così parlato di deregolamentazione, accompagnata
da una riregolamentazione. Non è un semplice gioco di parole.
Il concetto è preciso: stabilire regole valide. Cominciando
da questa: occorre riorganizzare i rapporti fra pubblica amministrazione
e cittadini (e imprese) in modo tale che ciascuno abbia di fronte,
a qualunque livello di governo, un solo interlocutore. Il concetto
dello "sportello unico", introdotto nella prassi amministrativa
italiana, sarebbe la più rilevante e significativa rivoluzione.
Ma vediamo altri esempi. Una società finanziaria italiana,
che opera anche in Francia, chiede al governo di Parigi l'autorizzazione
a svolgere certe attività, aumentando in corrispondenza il
capitale sociale. La domanda viene inoltrata ,al ministero dell'Economia
e delle Finanze, direzione del Tesoro. La pratica coinvolge vari ministeri,
molteplici enti. Ma per l'amministrazione francese questo è
un suo problema interno, com'è giusto. La domanda è
unica ed unica la risposta che giunge alla società dopo poco
più di due mesi. Quella società, però, attende
ancora i timbri italiani. E sono trascorsi più di dieci mesi.
Dalle attese burocratiche, (che peraltro presentano un costo molto
elevato, perchè bloccano l'operatività delle imprese),
alle attese nei pagamenti. Ecco un dato: i pagamenti delle Unità
sanitarie locali ai fornitori avvengono mediamente dopo circa 400
giorni. Negli altri Paesi i tempi di attesa sono quelli normali: il
saldo entro 90 giorni. Chi paga, in Italia, i costi di questa differenza?
E veniamo ai costi inutili. Una recente indagine dell'Assolombarda
ha quantificato i costi che un'impresa sostiene per svolgere attività
non direttamente collegate alla produzione di beni e servizi. Eccoli:
nel 1983 sono stati pari a circa il 4% del totale del costo del lavoro
nelle imprese da 11 a 35 addetti; al 3,3% nelle imprese da 36 a 100
addetti; al 3,2% in quelle da 101 a 250 addetti; al 3,3% in quelle
con oltre 250 addetti. I costi "sommersi" di un'impresa
sono direttamente proporzionali alle disposizioni che regolamentano
atti inutili.
I fatti hanno dato ragione a quanti hanno deregolamentato. Lasciamo
stare l'esempio degli Stati Uniti e guardiamo al nostro interno. Alcuni
vincoli amministrativi sul credito (e ci riferiamo alle norme sul
massimale dei prestiti) sono stati tolti un anno fa. I timori erano
molti: si sosteneva che quei vincoli non potevano essere rimossi in
presenza di un deficit pubblico enorme. Eppure il deficit non si è
ridotto, i vincoli sono caduti e in questo primo periodo del "nuovo
corso" non si è verificato quella perdita complessiva
di controllo sulle grandezze monetarie e creditizie che per lungo
tempo aveva trattenuto le autorità dall'imboccare la nuova
strategia. Il coraggio è stato premiato.
Altrettanto coraggio bisogna avere nel ridurre i vincoli ai movimenti
valutari. I tempi appaiono maturi per compiere passi significativi,
superando progressivamente la situazione attuale: il nostro Paese
ha un'internazionalizzazione nel movimento di merci pari a tre quarti
il valore del prodotto interno lordo, mentre le attività finanziarie
proiettate all'esterno sul totale non raggiungono il 4%.
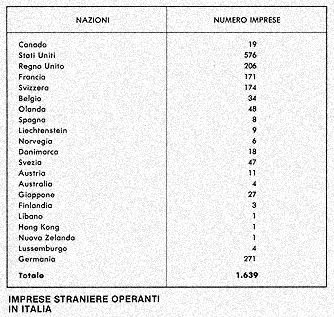
Quando si è
constatato, di recente, che le aziende straniere avevano riscoperto
l'Italia (nel triennio 1982-84 gli investimenti diretti dall'estero
hanno superato i 3.000 miliardi), ecco che si è parlato di
imporre limiti, di individuare parametri, di regolamentare l'attività
delle multinazionali in Italia. Proposte antistoriche, tanto che Business
International, che rappresenta decine di imprese estere operanti nel
nostro Paese, ha fatto sapere che investimenti già decisi sono
stati messi "in sospensiva", in attesa di chiarimenti da
parte del ministero dell'Industria e delle autorità politico-amministrative
italiane.
I pericoli sono qui, nella mancanza di coerenza di molti nostri politici,
nella suggestione che certi miti ancora esercitano. Eppure non ci
sono alternative: il mondo sta cambiando. E la deregulation, attuata
con realismo, serve a far cambiare anche l'Italia. Sbagliando il meno
possibile.
L'Italia del
2001
L'Italia del 2000 sarà più "piccola". Oggi
ha più di 57 milioni di abitanti, fra vent'anni ne avrà
quasi un milione in meno. E ancora: la quota di anziani salirà
a 12,5 milioni di persone; due italiani su nove avranno più
di 60 anni.
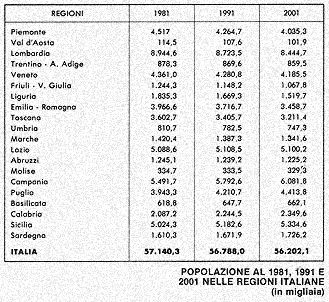
Questi dati demografici, che denunciano la "crescita zero"
(o sottozero) della nostra natalità, si rifletteranno sul mercato
del lavoro. Ma in che modo? Risponde la Fondazione Agnelli: ci saranno
più anziani (teoricamente pensionabili) e i giovani varcheranno
più tardi le soglie del mondo del lavoro, per la diffusione
maggiore della scolarità, (oggi, 73 giovani su 100 frequentano
le scuole superiori, ma si è sulla strada del rapporto 93 a
100, che è quello attuale del Giappone); ma, in compenso, aumenterà
il numero degli anziani "in salute", quindi disponibili
a lavorare oltre l'età della pensione; e sarà più
alto anche il numero delle donne disposte ad entrare nel mondo del
lavoro. Oggi sono inserite, o desiderano esserlo, 26 donne su 100;
a fine secolo saremo intorno al 30%, più vicino alla media
americana (39,8%) e giapponese (36,3%).
Tutto questo vuoi dire una cosa: che nel 2000 sarà maggiore,
e non minore, la forza-lavoro sul mercato. I futurologi stimano che
a fine secolo saranno necessari 3,6 milioni di posti di lavoro in
più, per un tasso di disoccupazione (ottimistico, in realtà)
del 5%. Ma come si giunge a questa cifra? Si è stimata la forza-lavoro
attuale, anche nella proiezione di quella futura; si è calcolata
la quota odierna di "sommerso", (circa due milioni di posti,
pari al 13,9% degli addetti "ufficiali"); si è calcolato
il numero dei "disoccupati mascherati" (i cassintegrati,
che risultano occupati solo nelle statistiche); si è dovuto
tener conto dell'elevamento a 65 anni dell'età della pensione
previsto dalla riforma previdenziale di De Michelis e del numero delle
donne che si dichiareranno disponibili al lavoro in più; con
la riserva di circa un terzo di posti, che non si dovranno creare
ex novo, dovendo piuttosto "emergere" dal cono d'ombra del
"sommerso". E con forti squilibri regionali: al Nord, soprattutto
in Piemonte, Val d'Aosta, Emilia e Toscana, la manodopera potrà
essere insufficiente, mentre in diverse aree del Sud, in particolare
là dove la natalità continuo ad essere elevata, sarà
ancora eccedente.
In cambio, struttura di lavoro meno rigida: pochi saranno in grado
di fare lo stesso lavoro per tutta la vita; molti dovranno alternare
periodi di lavoro a "momenti di ritorno a scuola", per la
formazione obbligatoria degli adulti; molti posti saranno part-time,
(oggi la percentuale italiana del part-time è del 2,7%, la
più bassa d'Europa; e dovrà salire almeno intorno al
13%). Altri posti di lavoro si creeranno per lo sviluppo del sistema
sanitario nazionale, con nuovi (e immensi) bisogni ai quali lo Stato
non potrà far fronte, e che porteranno alla nascita di forme
di mutuo aiuto, nate spontaneamente, o sostenute dal sistema assicurativo.
Meno ragazzi nelle scuole: e si prevede che dalle 41.000 classi in
eccesso si potranno ricavare abitazioni per 200.000 persone. Si trasformeranno
i consumi: più viaggi, più medicine, più hobbies.
E il panorama mondiale presenterà un drammatico contrasto:
più di metà della popolazione del mondo vivrà
in Paesi asiatici, sovrappopolati e a basso reddito; 88 persone su
100 vivranno sotto regimi dittatoriali (di qualsiasi colore politico)
e solo 12 su 100 in regimi ad economia di mercato.