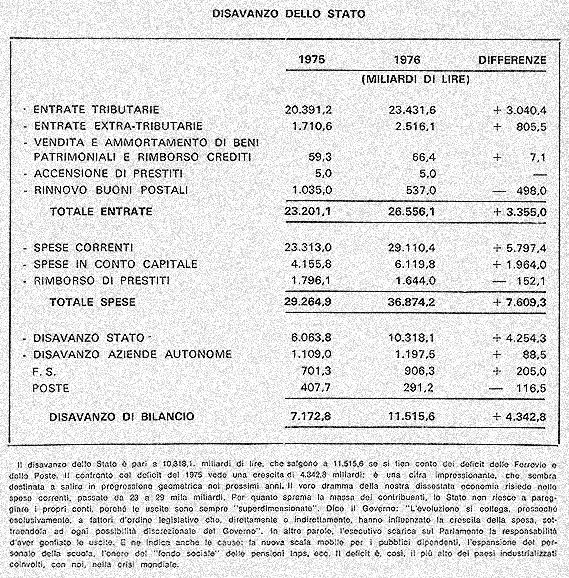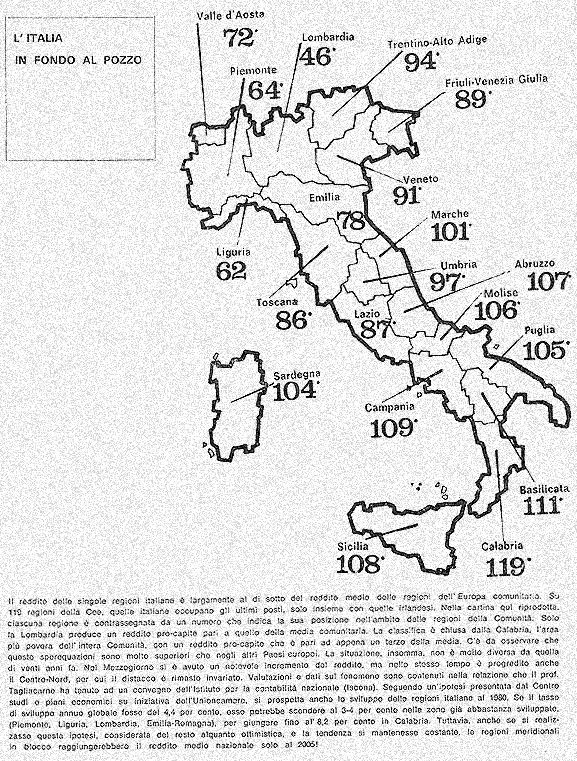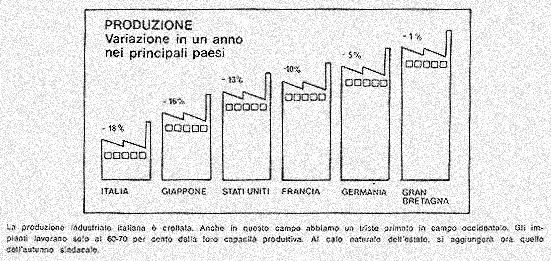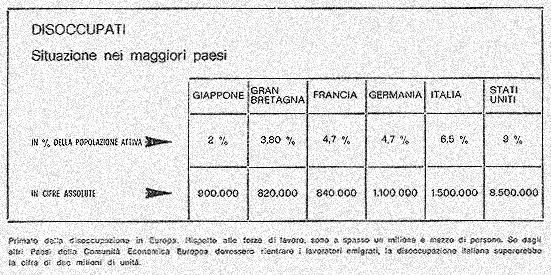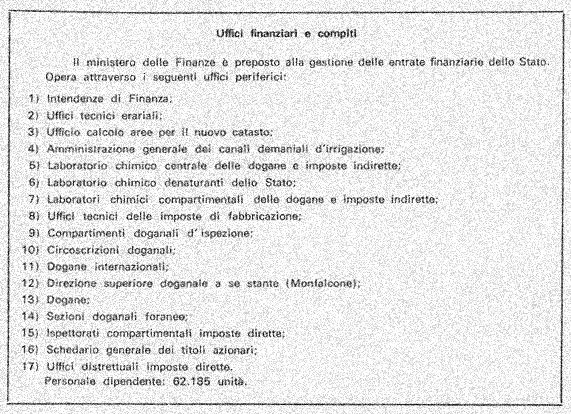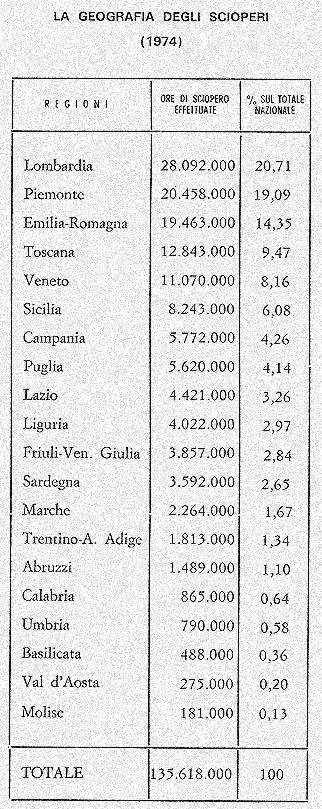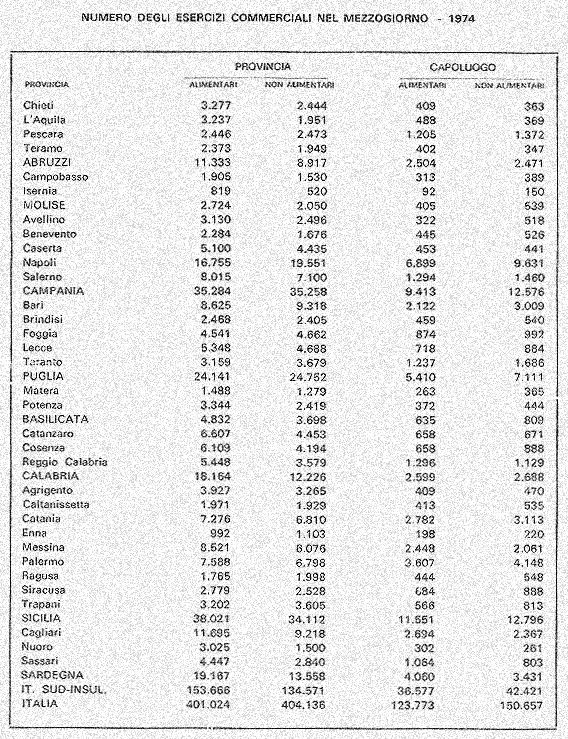La
crisi che ha investito il nostro Paese ha cause remote e prossime, ma
facilmente individuabili, alle quali non si pone alcun rimedio - La
situazione economica e le prospettive per gli anni '80 - Mezzogiorno
ed Europa comunitaria.
Il passivo del
bilancio dello Stato raggiungerà nel 1976 la cifra record di
11.516 miliardi di lire. I passivi dei bilanci degli enti locali sono
calcolati intorno ai 20.000 miliardi. Gli ospedali italiani hanno
debiti per circa 3.000 miliardi. I carrozzoni mutualistici devono
agli ospedali oltre 2.000 miliardi, ma non pagano per mancanza di
quattrini. La nostra bilancia dei pagamenti con l'estero segna una
vertiginosa curva discendente. Le Partecipazioni Statali sono in crisi
(l'equilibrio economico delle aziende dell'Iri è precario;
Alfa Romeo, Alfasud e Alitalia - come ha esplicitamente affermato
il prof. Petrilli - "sono coinvolte in crisi di portata mondiale",
le altre imprese del gruppo sono "sottocapitalizzate", mancano
indirizzi governativi, si fanno salvataggi indiscriminati, si coprono
oneri derivanti da "condizionamenti di natura politica".
A risollevare l'Eni dalle rovine e dalla corruzione è stato
mandato un barese di provate capacità e dalle mani pulite,
l'avvocato Sette. Un precipitoso cambio di guardia si è reso
necessario per l'Egam. La Gepi è una macchina mangiasoldi.
L'Efim stagna). Mentre continua a "dilatarsi la base monetaria"
(in parole povere, si allarga l'inflazione), lo sviluppo economico
langue, la cassa integrazione impera, l'assenteismo dilaga, la contingenza
imperversa, si svaluta per contenere la recessione, l'autunno sindacale
è dietro l'angolo, gli imprenditori privati - nulla più
avendo da investire - chiudono bottega o svendono, la disoccupazione
si gonfia, la sottoccupazione è assurta a sistema. Assistiamo
al progressivo disfacimento degli ultimi valori morali e civili su
cui si fondavano una politica e un'economia che pure avevano portato
l'Italia nel novero dei Paesi più industrializzati del mondo.
Massimo esempio di anarchia funzionante, il nostro Paese ha fatto
i conti delle recenti ferie: un popolo di indebitati fino al collo
ha sperperato tra luglio e agosto la bazzeccola di 5.000 miliardi
di lire!
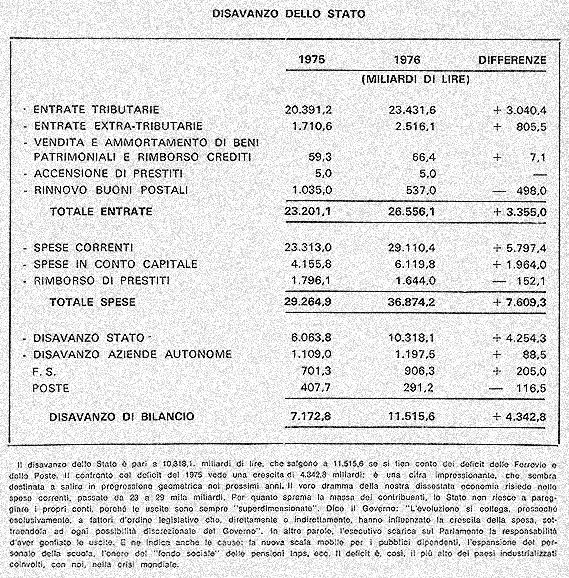
I venti anni che seguirono all'entrata in vigore della Costituzione
repubblicana ci diedero una nazione ricca di fermenti e di energie
umane. Ricostruito il Paese, alla laboriosità e alla sobrietà
tradizionali le masse univano una dignità e una speranza nuove.
:Cresceva lo spirito imprenditoriale, la scuola e l'università
selezionavano qualitativamente, nelle amministrazioni pubbliche cominciavano
a cadere i vecchi formalismi, disponevamo delle tecniche e dei mezzi
produttivi più avanzati, avevamo una gran voglia di lavorare,
di realizzare quel trasferimento verso una diversa sfera sociale che
è la molla di spinta in grado di garantire un'ascesa collettiva
e un benessere sconosciuti nel passato. Non è che mancassero
le tensioni. C'erano, come sempre, ingiustizie, perfidie, soprusi.
La vecchia (e anche nobile) idea dello Stato centralizzato che tutto
vede e a tutto provvede era, almeno nelle società occidentali,
ormai tramontata; mentre - sull'altro fronte - si moltiplicavano le
richieste di intervento nella sfera sociale. Era inoltre evidente
che il tentativo operato dai politici nell'immediato dopoguerra di
soddisfare queste domande mediante enti e organismi svincolati dall'apparato
statale tradizionale poteva considerarsi in massima parte fallito,
sia perché i servizi resi non erano snelli, sia per il malcostume
connaturato alla distribuzione di posti di sottogoverno. Per quel
che riguarda gli imprenditori, titolari di aziende consolidate, diventati
sempre più ricchi e (politicamente) potenti, si accorsero che
la nuova società non poteva fare a meno dei loro prodotti,
né dell'occupazione che essi assicuravano, né delle
espansioni vantaggiosamente "contrattate" (eterna preziosità
delle diseconomie del Mezzogiorno!): da quel momento diventò
per loro possibile trasferire sulla collettività i rischi e
gli oneri delle loro imprese, continuando però a goderne gli
utili. A loro volta, i politici scoprirono che la moltiplicazione
dei posti di lavoro e il consumismo erano estremamente produttivi
in termini elettorali, mentre un "accorto" uso degli strumenti
politici poteva dissetare l'enorme fame di quattrini degli apparati
partitici. Il centrosinistra nacque anche con l'ansia illuministica
di riqualificare e ridimensionare il "centro", e di attuare
le deleghe delle funzioni previste dalla carta costituzionale; mentre
dovevano essere del tutto ristrutturati - sul piano organizzativo,
procedurale, dei sistemi di reclutamento e selezione del personale,
e via dicendo - alcuni settori (Giustizia, Tesoro, Finanze, ecc.),
le cui funzioni, per essere connaturate col potere statale vero e
proprio, non potevano essere affidate ad alcun ente.
Cosa si è invece verificato? Non solo non si è mai posto
mano a una qualche innovazione concreta e sostanziale nei settori
su citati, ma se ne sono moltiplicati all'infinito le difficoltà
e gli incroci di competenze con iniziative occasionali e contingenti,
molto spesso demagogiche, che hanno trasformato quei centri in altrettanti
apparati mummificati che, posti di fronte a tentativi di operazioni
moderne, traumatizzanti, (come la riforma tributaria), sono rimasti
lettera morta. Perché? Perché non è possibile
innestare su un telaio decrepito sovrastrutture nuove. Su quel telaio
i politici continuano ad applicare iniziative confuse e velleitarie,
ciambelle di salvataggio corporative che, volendo accontentare alcuni,
e sempre gli stessi, (come ha dimostrato il 15 giugno) hanno spazientito
tutti.
Un milione e mezzo di disoccupati; è una cifra da primato per
l'Italia degli ultimi quindici anni. Nessun Paese europeo ha una percentuale
così alta (8,5 per cento della popolazione attiva) di gente
rimasta senza lavoro. La cassa integrazione è al limite dello
svuotamento. Ma non siamo ancora al tetto. Aziende di tutte le dimensioni
ne prospettano il ricorso. La produzione industriale è quella
che è, gli impianti lavorano al 60-70 per cento delle loro
capacità. In molte zone industriali il colpo d'occhio è
desolante: fabbriche chiuse, fabbriche occupate. Il costo della vita
aumenta a ritmi vertiginosi. L'Italia, si dice, è la malata
d'Europa. E' un'idiozia abissale, uno slogan logorato, che non rispecchia
realisticamente le cose. La clinica è affollata di molti altri
pazienti, europei e mondiali. Non c'è Paese industriale che
non abbia subito il contraccolpo della crisi petrolifera. Tutti hanno
i loro problemi. Ma gli altri, a dispetto nostro, si sono affrettati
a cercare i rimedi. Gli inglesi hanno varato severe misure per il
contenimento dei prezzi e dei salari; Londra ha scelto per obiettivo
l'inflazione e sta dedicando tutte le energie alla difesa del potere
d'acquisto della moneta. La Francia ha predisposto un piano per la
tutela delle aziende in difficoltà: rilancio degli investimenti
pubblici e protezionismo; l'unità politica ed economica europea
si è allontanata, ma i francesi se ne preoccupano ben poco.
Anche la Germania ha di fronte lo spettro della disoccupazione, ma
Bonn ha esplicitamente dichiarato che rispedirà nei Paesi d'origine
tutti gli emigranti.
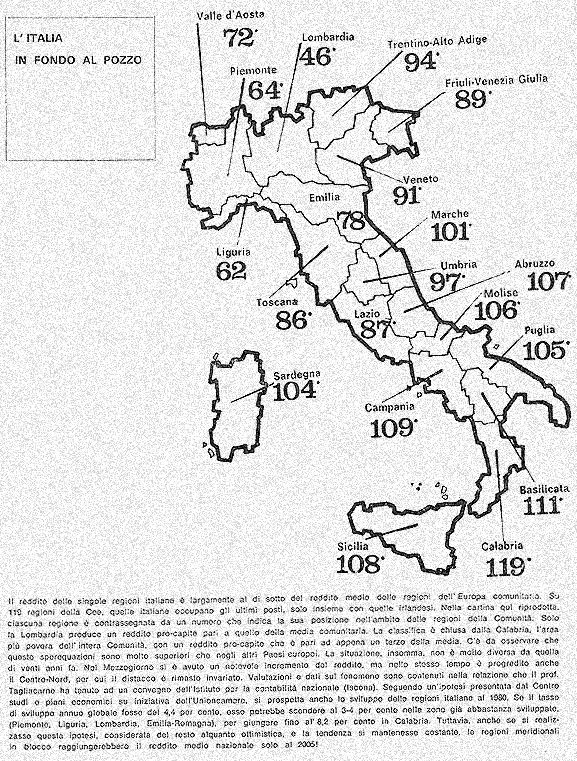
Soltanto ora noi abbiamo varato un "pacchetto" per avviare
la ripresa. I quattrini (quattromila miliardi) serviranno da volano
per rimettere in moto meccanismi arrugginiti, per provocare investimenti,
per difendere l'occupazione. Ma proprio qui cominciano le note polemiche.
Il "pacchetto" prevede una serie di "iniezioni di liquidità"
(secondo la definizione keynesiana) in favore della nostra economia.
E' stato però osservato che se l'economia italiana abbonda
di qualcosa, questa è proprio la liquidità! Vi è
un mare di carta stampata che circola, certamente eccessiva rispetto
al livello della produzione nazionale. Non ci troviamo dunque - come
ha osservato il direttore dell'Istituto di scienze economiche dell'Università
di Messina, Angelo Amato - di fronte a una politica "monetaria"
espansiva, ma ad una politica "di bilancio" keynesiana (anche
se il "pacchetto" è fuori bilancio) intesa all'espansione
mediante investimenti pubblici e incentivazioni di investimenti privati.
Solo - ha aggiunto lo studioso - che non si configura una situazione
economica come quella prevista da Keynes negli anni della crisi (1929
e seguenti). Oggi, la nostra situazione è tutta particolare,
e reclamerebbe, accanto alla cultura economica keynesiana, un pò
di immaginazione. Il "pacchetto" rappresenta una correzione
operata dalle nostre autorità finanziarie alla distribuzione
del reddito nazionale fra consumo e investimento. Fin qui, tutto bene.
Ma se si attingeranno al mercato finanziario i miliardi del "pacchetto"
in aggiunta ai circa 30.000 miliardi che saranno i disavanzi del bilancio
finanziario statale negli anni 1975-77, cosa rimarrà a disposizione
delle imprese private, che pure devono attingere al mercato finanziario
per i loro investimenti? Si dovrà far ricorso a nuove, enormi
emissioni di carta-moneta, ciò che provocherà un vertiginoso
aumento del livello generale dei prezzi. Allora, che fare? "Quando
le spese di consumo sono in eccesso rispetto a quelle di investimento,
che permangono ad un livello notevolmente inferiore a quello che consente
la piena occupazione, non è soltanto aumentando ed incentivando
gli investimenti che si può porre riparo, in una situazione
che non sia quella prevista dal Keynes degli anni trenta; ma bisognerà
contenere le spese di consumo, segnatamente le spese correnti statali
inutili. Le nuove spese di investimento si dovrebbero - in una situazione
come la nostra - scambiare con uguali riduzioni delle spese correnti
(di consumo) inutili. E si dovrebbe anche attivare il prelievo fiscale,
almeno in quei settori sui quali la riforma tributaria non grava,
come invece pesa sui redditi dei lavoratori che corrispondono l'imposta
per ritenuta".
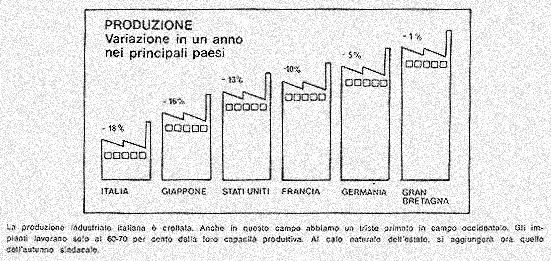
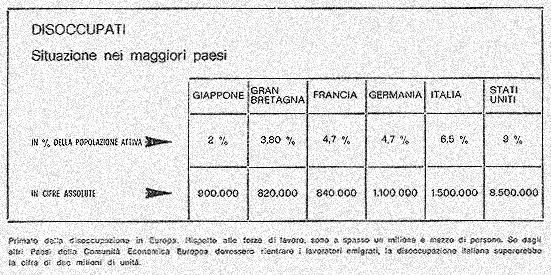
E veniamo alla bilancia dei pagamenti, fragilissima, in rapporto sia
alla difficile situazione economica, sia al pesante cumulo di debiti
già contratti. Parliamo di questi ultimi. In totale, ammontano
a tredici miliardi e mezzo di dollari, (ad un cambio di 660 lire per
dollaro, siamo a quota 8.580 miliardi di lire), sui quali occorre
pagare gli interessi, (l'ultimo prestito dal FMI - 620 miliardi di
lire - ha un tasso del 7,25 per cento: la media dei prestiti precedenti
è intorno al 9 per cento). Quest'anno dovranno essere pagati
- come conferma la relazione della Banca d'Italia - novecento miliardi
per interessi e circa seicento miliardi per rimborsi in conto capitale;
nel biennio seguente questi pagamenti saranno anche più cospicui.
Ora, il pericolo più evidente è che si debbano contrarre
nuovi debiti per pagare i precedenti, dal momento che a fronte dei
debiti di cui abbiamo detto possediamo riserve nette per non più
di 2.610,4 miliardi, anche se in questa cifra sono compresi i lingotti
d'oro (1.804 miliardi) contabilizzati ad un prezzo pari a meno di
un quarto del loro vero valore di mercato. In una situazione del genere,
è chiaro che molto dipenderà dall'evoluzione futura
degli scambi con l'estero, e dalla limitazione delle importazioni
anche ,se le aziende hanno le scorte al minimo, e per ricostituirle
debbono tornare ad acquistare materie prime. Infine, il petrolio,
che ci costa 400 miliardi al mese, potrebbe salire in ottobre, mentre
il rialzo del dollaro sul mercato dei cambi comporta che paghiamo
già di più le materie prime acquistate.
Altra indagine particolare meriterebbe la fuga precipitosa delle multinazionali
dal nostro Paese. La Dow Chemical trasferisce il centro decisionale
della Lepetit in Svizzera; la Citroën ha messo in vendita la
Maserati; la Bosch cerca compratori per la Philco; la Richardson-Merrel
è disposta a tutto pur di battersela da Napoli; la 3M dirotta
in Germania investimenti già previsti in Italia; la Leyland
vuol disfarsi della Innocenti. Questi aspetti clamorosi di una smobilitazione
fulminea hanno ragioni che anche l'industria nazionale conosce bene:
costo di lavoro giunto a livelli tedeschi, e di contro un numero di
ore perdute per assenteismo e scioperi che non ha uguali in tutto
il mondo. E poi: carenza di servizi pubblici, insicurezza personale,
protervia sindacale, incertezza del futuro politico, e una giungla
burocratica che è impossibile superare senza ricorrere alla
corruzione.
Parlare della burocrazia finanziaria italiana significa addentrarsi
in un labirinto kafkiano. Tanto per cominciare, esistono ben undici
amministrazioni finanziarie, (tasse, imposte dirette, imposte di fabbricazione,
monopoli, dogane, demanio, lotto, finanza locale, catasto, anagrafe
tributaria, guardia di finanza), che seguono tecniche e criteri operativi
diversi. Ciascuna di queste amministrazioni, è stato scritto,
è un piccolo mondo giuridico e burocratico, avulso dal resto
del sistema. A questa struttura molecolare corrispondono tanti mondi
chiusi, privi di flessibilità operativa, senza possibile intercambiabilità,
e spesso privi di una preparazione adeguata alle esigenze della tecnica
moderna. Basti pensare al fallimento del progetto "Atena"
(sigla magniloquente dell'Anagrafe tributaria elettronica nazionale),
che implicava la soluzione di una serie di problemi per i quali non
ci si era premuniti. E basti pensare - come ha rilevato la Corte dei
Conti - al mancato inquadramento dei dipendenti delle soppresse imposte
di consumo (quasi 8.000 unità), che in parte avrebbero potuto
coprire i vuoti esistenti. Capita così, che oggi i fuorilegge
e i sequestratari siano più informati del fisco sulla consistenza
patrimoniale dei cittadini. Oppure il fisco è informato, o
può essere informato, ma allora è legittimo il dubbio
che esista un rigoroso rapporto tra burocrati d'oro ed evasori d'acciaio.
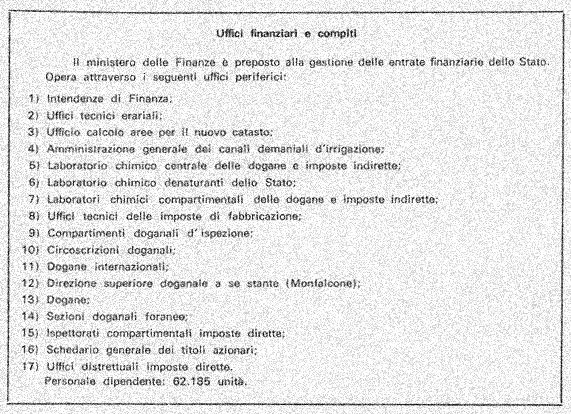
L'Ispe - Istituto di studi sulla programmazione economica, operante
nell'ambito del Bilancio, - nelle sue "Ipotesi di sviluppo industriale
al 1975 e al 1980", pone alcune ipotesi-obiettivo. Nel 1980,
l'offerta potenziale di lavoro dovrebbe essere pari a 20,3 milioni
di unità, superiore di un milione a quella attuale; gli occupati
in agricoltura dovrebbero scendere a 1,9 milioni (rispetto agli attuali
3 milioni); la conclusione è che l'offerta potenziale di lavoro
per i settori extra-agricoli al 1980 è pari a 18,4 milioni.
Considerato che, oggi, gli occupati nei settori extra-agricoli sono
15,6 milioni, si pone il problema di creare 2,8 milioni di posti di
lavoro addizionali in tale periodo. Questo - o poco meno, considerando
un minore esodo dai campi - è l'ordine di grandezza dell'obiettivo
da perseguire, che sarebbe già molto impegnativo per un'economia
in espansione, anzi in forte espansione produttiva, ma che è
pressoché mitico di fronte alla realtà della recessione
che stiamo vivendo.
Quali sono le condizioni per raggiungere quell'obiettivo? In termini
di investimenti, lo studio approfondisce l'esame al settore industriale
e giunge a un'indicazione di 32.000 miliardi a prezzi 1970 per sei
anni, dal 75 all'80: cioé, 5.300 miliardi annui. Ebbene, è
stato osservato che questa cifra è superiore di oltre il doppio
al volume degli investimenti industriali effettuati in Italia nel
quinquennio scorso (2.500 miliardi annui, sempre in lire 1970). Né
torna il discorso considerando le ipotesi-obiettivo poste per lo sviluppo
del "sistema" nel periodo 1975/80, che sono, in termini
reali di un 6,6 per cento (ipotesi "inferiore") e di un
7,6 per cento (ipotesi "superiore") l'anno del prodotto
lordo di tutte le attività economiche. Esse riflettono evidentemente
"il potenziale del sistema, cioé la sua capacità
di espandersi senza soffrire di limitazioni di ordine congiunturale
e soprattutto strutturale".
Ora per uscire dal caos in cui siamo finiti, sarebbe indispensabile
innanzitutto definire quale "sistema" vogliamo essere. La
struttura della politica corale, cui prendono parte governo, parlamento,
imprese, sindacati, partiti, correnti, clientele, inamovibili idoli,
fulminee meteore, ras d'alto bordo e legioni di mediocri figuri, ha
istituzionalizzato il marasma. Ha scritto Zappulli: "Si guardi
alla legge in apprestamento per i 20.000 miliardi da dare al Mezzogiorno;
manovrando fra gl'incentivi, il capitale risulterà gratuito;
nascerà così l'impresa senza rischio; anzi, per chi
sa fare, l'utile precederà l'impresa. Fiscalizzato il capitale,
fiscalizzati gli oneri sociali, non rimane che fiscalizzare anche
i salari. L'industria italiana verrà affidata, come gli ateliers
sociaux, ad appaltatori dell'occupazione. Sarebbe, questa, una politica
industriale?"
Se è questa la via per impedire la "ricostruzione capitalistica"
- come affermano i comunisti; ma questi almeno sono leali: dicono
quel che vogliono e quel che rifiutano - siamo sulla via giusta. Oltre
tutto, significa che oggi la struttura capitalistica italiana è
riconosciuta in via di sfacelo. Da quale parte, e come incominciare?
Che tipo di società rimetter su? Crollata l'economia capitalistica
- ma sarebbe più corretto dire: neocapitalistica - resta il
dirigismo statale al vertice di una piramide collettivizzata. Ora
come ora, le rovine del capitalismo Italiano - pubblico e privato
- non hanno più nulla da distribuire. Un malandato "Stato
sociale", ha dichiarato bancarotta nel momento in cui è
entrata in coma quella "Nazione imprenditoriale" alla quale,
dopo averle mosso una indegna crociata, ora chiede. un quasi impossibile
aiuto.
Due esempi sono illuminanti. Per pagare le spese di una politica dissennata,
è stato necessario, alla fine, svuotare la proprietà
di ogni contenuto. Le rendite, che si sarebbero scaricate su profitti
imprenditoriali e salari, sono state perseguitate; solo le peggiori,
quelle da speculazione, sono riuscite a salvarsi, grazie a protezioni
su cui la magistratura si è guardata bene dall'intervenire
con l'ampiezza e l'incisività opportune. E' sopravvissuta ancora
per qualche tempo la funzione degli immobili quali beni-rifugio, poi
la legge fiscale è intervenuta con l'Invim, paralizzando i
mercati immobiliari, e aggravando la crisi dell'edilizia. I proprietari,
che per millenni avevano temuto di essere espropriati dai poveri,
"si sono trovati poveri essi stessi", mentre quelli che
solo da poco sono pervenuti alla proprietà, dopo anni di sacrifici,
si sono accorti con rabbia di avere stretto appena un pugno di mosche.
Per la proprietà terriera si profila l'esproprio in nome della
legge, con le norme sull'affittanza: e a cosa serve questo esproprio,
forse a creare nuove unità produttive, cooperative, accorpamenti
autosufficienti? Serve solo quale premessa per un futuro "cambio
di padroni", niente di più, niente di meno. Siamo alla
demagogia come scienza di Stato.
Poi, gli scioperi. Generali, parziali, articolati, corporativi, settoriali,
centrali, autonomi, bianchi, politici, categoriali, a singhiozzo,
selvaggi. Per decenni abbiamo sentito politici di tutte le estrazioni
appellarsi alla Costituzione, reclamarne l'attuazione - chi non ricorda
i giorni che precedettero l'attuazione dell'ordinamento regionale,
"previsto :dalla Costituzione"? - guai, però, ad
accennare agli articoli 39 e 40, che imponevano la regolamentazione
dello sciopero. Oggi il discorso ècompletamente diverso: la
libera discrezionalità in fatto di astensione dal lavoro è
messa in dubbio. Perché? Perché i sindacati autonomi
non obbediscono alle direttive del sindacato unitario (Cgil-Cisl-Uil),
e agiscono in proprio, sconvolgendo piani e programmi "centrali".
Ora, se è vero che chi semina vento raccoglie tempesta, è
altrettanto vero che "nessun credito merita la recentissima indignazione
per gli scioperi corporativi o selvaggi, che fanno morire i degenti
in ospedale, affogano le città nella spazzatura, bloccano i
lavoratori nelle stazioni. Il Pci simula sia quando ostenta lo sdegno
sia quando si prende il capo fra le mani per escogitare un criterio
discriminante fra lo sciopero giusto e ingiusto. Odioso è lo
sciopero se prende in ostaggio gli utenti dei servizi pubblici, gestiti
da aziende dall'illimitata capacità di indebitarsi e di pagare.
Ma chi l'ha inventato? Il Pci si rivolga alla Cgil".
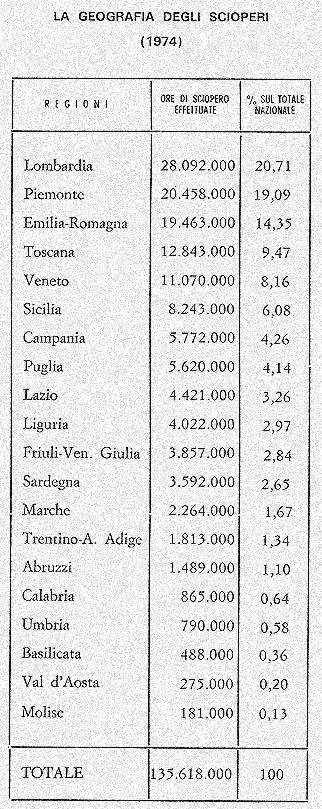
Infine, il Sud. Decenni di "politica meridionalistica" dello
Stato hanno senz'altro inciso nelle strutture economiche, sociali,
umane, del Mezzogiorno. Eppure, c'è dell'amaro in bocca. E'
la seconda volta, dal '63 ad oggi, che l'Italia si trova di fronte
alla recessione, e in tutt'e due le volte il prezzo più alto
è stato pagato dalle regioni meridionali: in termini di sviluppo,
in termini di occupazione, in termini di disponibilità di risorse.
Ecco, se c'è qualcuno che affoga, in occasioni del genere,
è sempre il Sud. Ma perché? Risponde il primo "Rapporto
sul Mezzogiorno", predisposto recentemente dalla Svimez: "Gli
eventi del 1974 non solo hanno ridimensionato i programmi di investimenti
nel Mezzogiorno già definiti, ma, più in generale, hanno
reso evidente che l'industrializzazione dovrà seguire direttrici
sensibilmente diverse da quelle seguite finora, per le quali le prospettive
di mercato sono divenute più incerte, come è il caso
dei grandi impianti di lavorazione di materie prime importate o degli
impianti manifatturieri realizzati negli anni più recenti,
soprattutto nel settore dell'automobile e in quelli ad esso strettamente
collegati". Alla polemica sulle "cattedrali nel deserto",
dunque, si aggiunge quest'altra: occorre allargare l'analisi critica
delle iniziative industriali da intraprendere nel Mezzogiorno, anche
in rapporto ai mutamenti dei costi delle convenienze sui mercati internazionali.
Altrimenti, non ci si deve sorprendere se entra in crisi un'Alfasud,
o se sono sconvolti i programmi di una Montedison per il rialzo dei
prezzi del petrolio: a Pomigliano d'Arco e a Brindisi c'erano quei
due gioielli" dell'industrializzazione meridionale, due vetrine
che ci erano costate un occhio, sulle quali le attuali basse pressioni
hanno richiamato la tempesta. Accade in questo modo che si gonfi in
"modo strano", come ha detto il neopresidente della Finanziaria
Meridionale. Ruffolo, il settore del commercio, con uno sviluppo tipico
di un'area ad alto benessere industriale, mentre il Sud è appena
(e non è ancora detto che ci resti), in un'area postagricola.
Se l' industria piange, l'agricoltura non ride. Perseguitata dalle
tasse, dal costo dei fertilizzanti, dalla mancanza di acqua, dai mediatori
e dalla Cee, l'agricoltura meridionale stenta ad uscire dalla sfera
del sottosviluppo. Soprattutto per quel che riguarda la posizione
del Sud nell'ambito comunitario i rischi sono enormi. Quest'agricoltura,
infatti, può uscire azzerata dagli accordi con i paesi del
Maghreb, (Algeria, Marocco e Tunisia), la cui concorrenza è
assolutamente insopportabile, se si tien conto della grandissima differenza
esistente in materia di costi di produzione. Nel Maghreb infatti i
salari sono molto bassi, e gli oneri previdenziali inesistenti. Di
conseguenza, olio, vino, pomodori, ortaggi e frutta "made in
Maghreb" invadono i mercati dell'Europa comunitaria, aiutati
- per colmo d'ironia - dal Feoga, che costa agli italiani quanto un'amante
di lusso.
Le cifre di Bruxelles, d'altro canto, parlano chiaro. Su 3.680 miliardi
che formano il bilancio agricolo della Cee (pari al 90 per cento del
totale), ben 3.410 miliardi sono spesi in iniziative di sostegno dei
prezzi per favorire i produttori lattiero-caseari e di cereali del
Nord-Europa. Secondo dati del nostro ministero dell'Agricoltura, soltanto
278 miliardi di lire, pari al 10 per cento del budget agricolo, sono
investiti in strutture, mentre la restante parte è assorbita
dalle massicce erogazioni in favore delle produzioni di burro e latte
(1.308 miliardi, il 40 per cento), di cereali (520 miliardi, il 16
per cento) e di carne (340 miliardi, il 10 per cento). Tanto per fare
un raffronto, i premi di vario genere e gli incentivi che vanno ai
produttori vitivinicoli toccano appena gli 85 miliardi di lire. E
la Francia respinge il nostro vino! E noi, limitando l'import di carne
dai Paesi dell'Est, chi abbiamo aiutato? La Francia innanzitutto,
e la Danimarca, che ci vendono i loro capi di bestiame: la Francia,
che sostiene il Maghreb per convenienza economica e politica; e la
Danimarca, tradizionalmente tiepida nei confronti dell'Europa comunitaria.
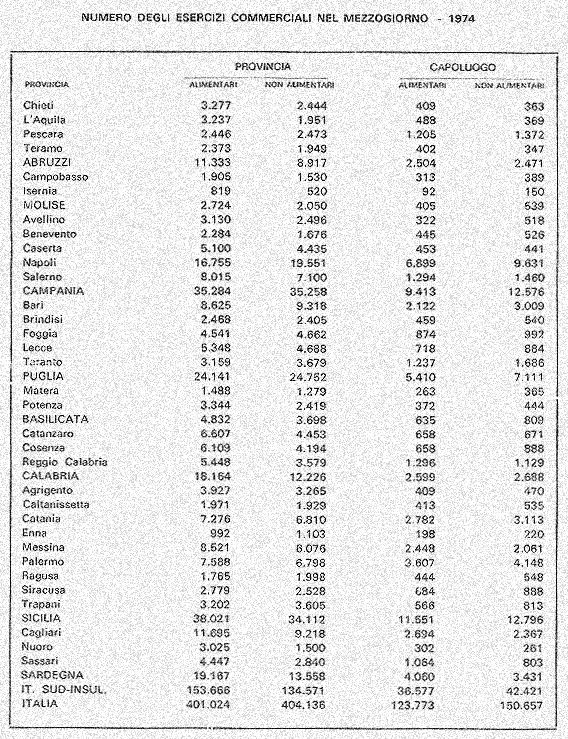
Ed ora i giovani. Da un'accurata indagine condotta appena qualche
mese fa, risulta che il tempo medio di attesa per il primo impiego
è pari a tre anni per il 40-45 per cento dei meridionali (contro
il 25 per cento della media nazionale). L'università diventa
dunque un'area di parcheggio, e la laurea uno strumento, una "referenza"
in più da presentare per una "qualunque occupazione".
Porse, il polso di questa situazione si può ascoltare meglio
esaminando la fine che fanno i giovani diplomati degli istituti tecnici
industriali, quelli che avrebbero dovuto sfornare gli elementi considerati
di punta delle classi lavoratrici italiane. Ebbene, su 100 elementi
considerati nell'indagine-campione, i disoccupati sono pari al 27,8
nel Sud (contro 14 del Centro-Nord); i parcheggiati nelle università
sono 38,2 (28,0 nel Centro-Nord); gli occupati sono 34 nelle regioni
meridionali (contro 58 del Centro-Nord).
La realtà della disoccupazione meridionale sta venendo fuori
anche da un'indagine del Censis, i cui dati non sono ancora disponibili.
Ma presso questo Centro studi sociali ci si è resi già
conto di come nel Sud non vi. sia alcun rapporto fra prospettive di
sviluppo economico di una data area e istituti di formazione professionale:
nelle aree meridionali si registra il 70 per cento circa di corsi
di formazione per l'industria, il resto per il commercio e, in misura
di gran lunga inferiore, per il turismo. In pratica, vuol dire creare
il 70 per cento di disoccupati. E speriamo che qualcuno venga a spiegarci
cosa dovremo fare delle masse di architetti usciti dall'università
di Reggio Calabria, dei laureati in Lettere o Materie Letterarie di
Lecce, degli esperti in Scienza dell'Informazione di Salerno. Saranno
esperti nella tecnica di sbarcare il lunario, clienti delle cosche
politiche, sottoccupati cronici, o redattori di decine di domande
di ammissione ai concorsi statali e parastatali.
Da tutto questo, la jacquerie, la rivolta, la nausea, l'odio per il
"sistema", la rabbia per il passato recente, il rifiuto
delle strutture politico-sociali, la contestazione di un'etica fondata
sulla grazia ricevuta. Eppure, se una ricchezza ancora ha questo nostro
incredibile - e indescrivibile - Paese, essa risiede proprio nella
qualità del materiale umano, nella praticità dell'intelligenza,
nella duttilità della fantasia. Di fronte a tanto, che criminosa
politica dello spreco!
AGRICOLTURA E
MEZZOGIORNO
L'economia agraria
delle regioni meridionali, secondo una recente stima della Confagricoltura,
è basata per il sessanta per cento sulla produzione vitivinicola
(570 miliardi di lire nel 1974), su quella degli ortaggi (680 miliardi
di lire), degli agrumi e della frutta (540 miliardi di lire).
Il reddito complessivo di queste colture, che occupano un milione
di addetti, è stimato sui 1.800 miliardi di lire. Per un raffronto,
si pensi che il reddito totale dell'agricoltura meridionale è
stato, nel 1974, di 3.340 miliardi di lire.
Il vino, che interessa in modo particolare la Puglia e la Sicilia,
(45 per cento della produzione nazionale), è una voce indiscutibilmente
attiva dei nostro interscambio. Lo scorso anno abbiamo esportato vino
per 203,2 miliardi di lire (di cui 139,5 miliardi nella sola Cee).
Gli agrumi italiani, (colture in Sicilia, Calabria, e Campania, e,
da poco, anche in Basilicata), sono stati esportati, sempre nel '74,
soprattutto fuori della Cee (57,0 miliardi di lire). L'esportazione
degli ortaggi (60 per cento dei quali prodotto nel Mezzogiorno) è
stata di 123,9 miliardi di lire (di cui 90,3 nella Cee). La frutta
fresca esportata, (anche qui le produzioni dei Sud raggiungono il
60 per cento del totale nazionale), ha raggiunto un valore di 290,8
miliardi di lire, (221,1 dei quali nella Cee). Infine, le esportazioni
di conserve di pomodoro sono state pari a 114,3 miliardi di lire (69,7
nella Cee), e quelle di conserve e succhi di frutta a 93,3 miliardi
di lire (69,8 nella Cee).
Analisi delle cifre
La distribuzione
delle ore di sciopero secondo il ramo di attività vede al primo
posto l'industria manifatturiera, con 81 milioni 286 mila ore, corrispondenti
al 59,94 per cento dei totale, così ripartite per settore:
industrie metallurgiche e meccaniche 45 milioni 223 mila (33,35 per
cento); industria chimica e della gomma 9 milioni e 913 mila ore (7,31
per cento); industria tessile 7 milioni 589 mila ore (5,59 per cento);
industrie alimentari, dei tabacco e affini 4 milioni 918 mila ore
(3,63 per cento); industria dei vestiario e dell'abbigliamento 3 milioni
332 mila ore (2,46 per cento); industria cartaria e poligrafica 2
milioni 9 mila ore (1,48 per cento); industrie della lavorazione dei
minerali non metalliferi 1 milione 895 mila (1,40 per cento); industrie
delle calzature, pelli e affini 1 milione 671 mila (1,23 per cento);
industrie dei legno e dei mobilio 1 milione 660 mila (1,22 per cento);
altre industrie manifatturiere 3 milioni 76 mila (2,27 per cento).
Seguono la Pubblica Amministrazione con 11 milioni 912 mila ore (8,78
per cento); l'industria delle costruzioni con 9 milioni 833 mila ore
(7,25 per cento); l'agricoltura, foreste e pesca con 9 milioni 766
mila ore (7,20 per cento); i servizi e le attività sociali
con 7 milioni 321 mila ore (5,40 per cento); i trasporti e comunicazioni
con 6 milioni 176 mila ore (4,56 per cento); il commercio con 5 milioni
769 mila ore (1,03 per cento); l'elettricità, gas e acqua con
1 milione 397 mila ore (1,03 per cento); e le industrie estrattive
con 756 mila ore (0,56 per cento).
Per quel che riguarda le causo, il 54,78 per cento delle ore di sciopero
ha riguardato le rivendicazioni salariali; il 20,64 per cento il rinnovo
dei contratti di lavoro; l'8 per cento rivendicazioni economiche e
normative; il 2,89 per cento la solidarietà ad altre categorie
di lavoratori; lo 0,69 per cento il licenziamento di lavoratori; lo
0,47 per cento il mancato pagamento delle spettanze arretrate; lo
0,28 per cento la sospensione di operai dal lavoro; 17 milioni 973
mila ore di sciopero, pari al 13,25 per cento del totale, sono stati
effettuati per "cause diverse".
Le regioni in cui si sono verificati i più sensibili aumenti
rispetto all'anno precedente sono la Sicilia, col 30,9 per cento di
ore di sciopero in più; la Sardegna, col 41 per cento in più;
la Calabria, col 24,8 per cento in più; le Marche, col 5,4
per cento in più.
Quanto ai rami di attività, si è registrato un aumento
delle ore di sciopero nell'industria delle costruzioni, col 333,7
per cento in più; nelle industrie alimentari, dei tabacco e
affini, col 377,5 per cento in più; nel l'agricoltura, col
64,7 per cento in più; nell'industria chimica e della gomma,
col 25,4 per cento in più; nella Pubblica Amministrazione,
col 19 per cento in più; nell'industria del vestiario e dell'abbigliamento,
col 97,4 per cento in più; nel settore dei credito e delle
assicurazioni, col 270 per cento in più.
Lo sciopero
altrove
Repubblica Federale
Tedesca. La costituzione dei 1949 non menziona il diritto di sciopero.
Lo sciopero è considerato come una libertà "di
fatto". L'art. 33 della carta costituzionale proibisce però
esplicitamente ogni sciopero nei servizi pubblici. La legislazione
ordinaria ha definito lo sciopero come il "mezzo estremo"
per realizzare le proprie richieste, e ha introdotto una serie di
limiti: deve perseguire interessi collettivi, deve attuarsi direttamente
nei confronti della controparte dei rapporto di lavoro, dev'essere
dichiarato dal sindacato e non da gruppi di lavoratori, deve attuarsi
con azioni "leali".
Inghilterra. Il diritto di sciopero, che nessuna norma di legge sancisce,
è considerato come una "libertà". La politica
dei redditi, che garantisce con legge il blocco dei salari, prevede
dure sanzioni penali per gli scioperi tendenti a miglioramenti delle
retribuzioni. La giurisprudenza britannica considera illegali la mancanza
di preavviso in qualunque sciopero e le interruzioni di lavoro di
categorie addette a servizi pubblici, come le aziende elettriche,
del gas, dell'acqua.
Francia. Anche se la situazione francese presenta molte analogie con
quella italiana, (e la stessa dizione sul diritto di sciopero che
c'è nella Costituzione italiana), la legge dei 1950 stabilisce
una serie di limitazioni. La giurisprudenza della Corte di Cassazione
proibisce alcune forme di sciopero (non collaborazione, sciopero bianco,
sciopero di solidarietà se non tra dipendenti della stessa
azienda). E' vietato lo sciopero ai funzionari statali che svolgono
particolari attività amministrative o sociali. E' imposto preavviso
di cinque giorni per lo sciopero dei dipendenti dei pubblici servizi.
Il governo può mobilitare persone atte ad assicurare il mantenimento
di servizi essenziali in "circostanze particolarmente critiche".
Belgio e Olanda. La Costituzione belga e quella olandese non hanno
alcuna norma sul diritto di sciopero. La legislazione ordinaria considera
"colpa grave" lo sciopero politico, la non-collaborazione,
l'ostruzionismo. In Belgio esiste un rigido divieto di sciopero nei
servizi pubblici. Una legge conferisce alle autorità la facoltà
di mobilitare alcune categorie di lavoratori durante gli scioperi
"nell'interesse nazionale". In Olanda, anche se con leggi
diverse, esistono analoghe limitazioni e disposizioni.
Paesi scandinavi e Svizzera. Nessuna legge disciplina io sciopero,
che è pressoché inesistente, e rigidamente delimitato
dallo Stato. C'è una Corte dei lavoro che conferisce valore
esecutivo ai contratti collettivi e risolve i conflitti per la loro
applicazione. Per alcune categorie, (funzionari statali, ferrovieri),
lo sciopero è vietato.